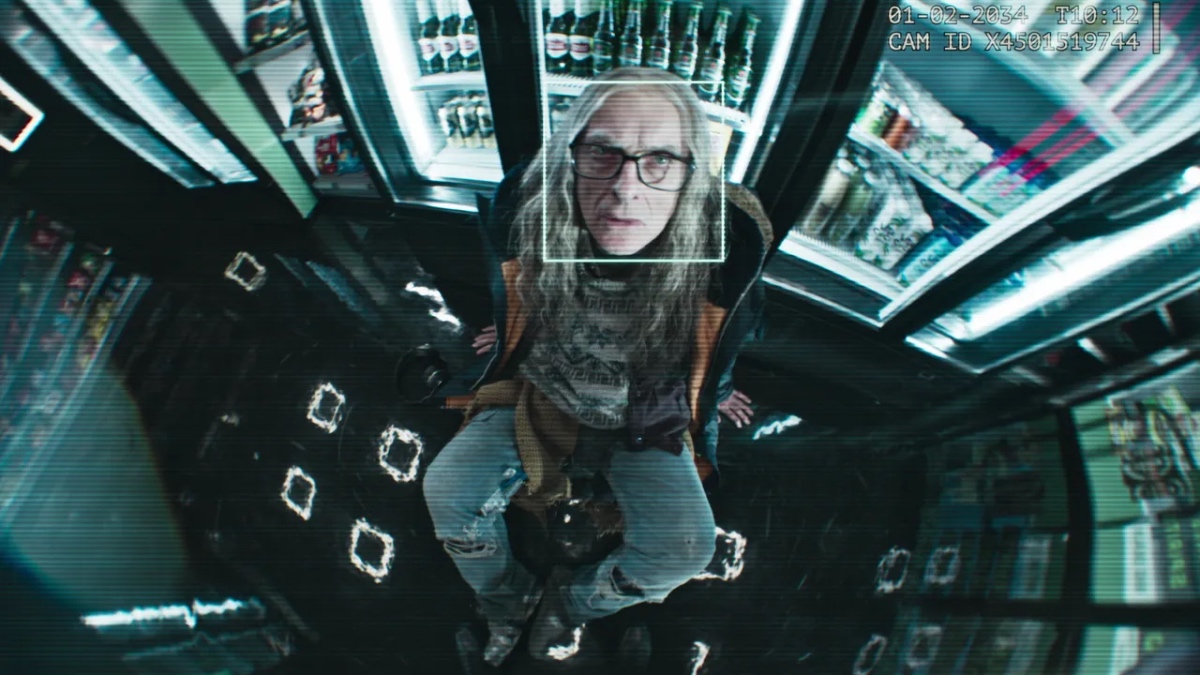Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
ATTENZIONE: il seguente articolo contiene spoiler su 1923.
Il finale di 1923 ci ha lasciati sconvolti, ma soddisfatti. Consapevoli che ciò che abbiamo visto è narrativamente riuscito, eppure devastante nei suoi effetti emotivi. Come se la serie ci avesse accompagnato con forza dentro un baratro, solo per lasciarci lì, spettatori fermi e impotenti, con il rumore degli spari ancora nelle orecchie e i volti dei sopravvissuti impressi nella memoria.
Siamo di fronte a una chiusura coerente e tragica, che non cerca di consolare né di ricucire. 1923 si congeda dal suo pubblico senza promesse e senza eroi, solo con una lunga scia di sangue, silenzi e perdite. È una fine che non ha il respiro epico della vittoria, ma la stanchezza amara della sopravvivenza.
Lo capiamo fin dalle prime battute dell’ultimo episodio, che dura quasi due ore: un tempo dilatato che non è solo esigenza narrativa, ma anche una presa d’atto. Taylor Sheridan sembra aver realizzato che la storia non poteva essere chiusa in fretta, che serviva spazio per contenere tutta la violenza, la disperazione, la memoria. E così 1923 si prende il suo tempo, come se fosse consapevole che non ci sarà un domani. Solo un presente terminale, lucido e doloroso.
Il prezzo del mito
1923 non è solo una storia familiare o una serie western. È il racconto di una decomposizione, quella del sogno americano rurale, della frontiera, della famiglia come baluardo. In questo senso, la frase pronunciata dal medico sul treno — È una lunga storia. Di quelle memorabili — assume un significato quasi funebre. Non è il racconto glorioso di un’epopea, ma la narrazione di una caduta, di un’epoca che si chiude con violenza e sacrifici senza redenzione.
La sensazione finale non è quella del trionfo, ma quella di essere sopravvissuti a un massacro. Non in senso figurato, ma letterale: una valanga di sangue, morti e vendette, in cui i protagonisti si muovono come fantasmi. Spencer, Alex, Jacob, Cara, Banner, Teonna: nessuno ne esce illeso. Nemmeno lo spettatore.
Abbiamo assistito a qualcosa di potente, perfino affascinante, ma sappiamo che la bellezza ha avuto un costo altissimo. Forse è questo il lascito più onesto di quest’ultima puntata. E, forse, di tutta la serie. Mostrarci che il mito fondativo dell’America non può essere celebrato senza pagarne le conseguenze.
L’epica della perdita in 1923
L’incontro tra Spencer e Alex è, a suo modo, l’ultima grande scena romantica della serie, e non poteva essere che disperata. Il caso, più che il destino, li riunisce in un modo che sfiora l’inverosimile, ma a quel punto lo spettatore accetta. Perché se non si fossero ritrovati, sarebbe stato davvero eccessivo. Insopportabile.
Eppure anche qui, la felicità è solo un attimo tra due dolori: Alex è mezza congelata, morente. Bellissima. Spencer la stringe a sé, lei riesce perfino a rimproverarlo con tenerezza, a dargli uno schiaffetto. Ma il tempo non è dalla loro parte. L’incontro è struggente proprio perché non risolve, non sistema nulla. È solo un frammento, l’illusione di una salvezza. Il vero addio avviene subito dopo, sul treno, quando Spencer parte per compiere la sua vendetta. Alex lo guarda andare via, consapevole che potrebbe non rivederlo mai più.
Qui entra in gioco la voce di Elsa, fuori campo, che ci riporta a quella genealogia sospesa che attraversa l’intero universo narrativo dei Dutton. Elsa dà voce all’animo di Alex, ma anche alla malinconia profonda che accompagna tutta la serie. Come se ci dicesse che, alla fine, nessuna redenzione è possibile. Solo resistenza.
Donne forti, donne sacrificali

Uno dei punti più controversi e affascinanti della serie è il ruolo delle donne. E che quest’ultima puntata conferma, se mai ce ne fosse bisogno. Alex, Cara, Elizabeth, Teonna: personaggi centrali, mai marginali, eppure costretti a incarnare il dolore.
Quello di Alex, in 1923, è forse il personaggio più riuscito. Non solo per la forza con cui affronta le avversità, ma per la complessità con cui è costruita. È sfortunata e porta sfortuna, ci dice la sua storia, ma lei non si arrende. È l’unica donna, forse, a scegliere il proprio destino fino alla fine, a voler vedere l’uomo che ama anche solo per un’ultima volta, anche sapendo che morirà. Non può correre nei campi del Montana, non vedrà mai lo Yellowstone, ma ha vissuto fino all’ultimo secondo con una volontà feroce. Ed è per questo che il suo addio ci strazia più di tutti.
Al contrario delle altre donne della serie, Elizabeth sembra scomparire nel momento in cui avrebbe più diritto a essere vista. Ha perso Jack, ha perso la sua nuova casa casa, la sua nuova famiglia, è rimasta sola. E proprio quando decide di andarsene, schiacciata dal dolore, riceve da Cara una frase durissima, un ammonimento che suona come un congedo definitivo: “Lo dimenticherai.”
È una scena spiazzante, persino crudele. Non solo perché riduce a parentesi un amore comunque profondo, ma perché nega a Elizabeth il riconoscimento del suo stesso lutto. Cara, che pure ha uno spessore emotivo e morale immenso, sembra ritrarsi, prendere le distanze. Come se la ragazza non appartenesse più al cerchio dei Dutton. Come se la morte di Jack avesse interrotto ogni legame, ogni diritto alla memoria.
Eppure Elizabeth porta in grembo il figlio di un Dutton. Un dettaglio gigantesco che, in quella scena, sembra dissolversi nell’aria. È come se la sua gravidanza non bastasse a garantirle un posto, una protezione, una forma di continuità. Ci si sarebbe forse aspettati che Cara la tenesse vicino, che la accogliesse nella condivisione del dolore, nella resistenza quotidiana. Anche se sappiamo che Elizabeth non è una donna facile da accudire, è pur sempre una sopravvissuta. È rimasta, ha combattuto, ha perso tutto.
E invece, in un paradosso narrativo e simbolico, Cara tiene in braccio il figlio di Spencer e sembra preferire Alex, morta, a Elizabeth viva. Come se preferisse eleggere a simbolo della parte femminile dei Dutton il ricordo, tragico e romantico anziché la realtà.
A questo punto si solleva una domanda: chi merita di essere ricordato? Chi ha diritto a restare parte della storia, e chi ne viene escluso?
Elizabeth non è meno coraggiosa, né meno sacrificata delle altre. Ma non ha l’alone mitico che protegge Alex. O la stessa Cara. La sua sofferenza è concreta, disordinata, non narrabile. E forse è per questo che viene liquidata in modo tanto brutale.
Cara scivola nel giudizio senza appello. Giudica e decide chi è degno e chi no di fare parte del clan Dutton. Dando alla scena finale una separazione definitiva che lascia l’amaro in bocca. Perché non c’è riconciliazione nel dolore comune della perdita di Jack. Con la differenza che Cara ha già chi puoi aiutarla a sopravvivere e andare avanti. Mentre Elizabeth è destinata ad arrangiarsi.
Teonna: la fuga impossibile
In questo scenario così cupo, Teonna è l’unica che ha un futuro. La sua vicenda, però, rimane del tutto separata dal resto. Pensavamo che, prima o poi, il suo arco narrativo si sarebbe intrecciato con quello dei Dutton. E invece resta autonomo, quasi parallelo. Ma forse è giusto così.
Teonna ha pagato tutto in anticipo: le umiliazioni, la violenza, la fuga, la perdita. La sua libertà non è un premio, ma il risultato di un errore del sistema. È salva solo perché il meccanismo che avrebbe dovuto incastrarla è stranamente contorto (e corrotto) per funzionare. Nessuna giustizia, solo uno scarto fortuito della macchina dell’oppressione. È ironico, quasi beffardo. Ma forse anche questa è una verità amara che la serie vuole dirci: non esiste riscatto vero, solo sopravvivenza.
I Dutton: i buoni tra virgolette

La vendetta di Spencer è una scarica di adrenalina e sangue. Eppure non ci restituisce un eroe. Anzi, ci ricorda che anche i “buoni” hanno le mani lorde. Spencer non rappresenta la legge. Non è giustiziere, è carnefice. Whitfield muore, Lindy con lui. Jacob assiste in silenzio, mentre indossa la stella dello sceriffo. Un dettaglio che Whitfield sottolinea, nel disperato tentativo di salvarsi chiede un processo perché sa già come andrebbero le cose. I suoi soldi potrebbero salvarlo. Ma in questo caso il processo non esiste. In 1923 esiste solo la legge degli uomini disperati.
In questo contesto, Banner si rivela personaggio chiave. Il suo tradimento di Whitfield è l’unico gesto etico, in un mondo dove l’etica sembra morta. Non lo fa per altruismo, ma per coerenza: rispetta Jacob perché sono simili, entrambi sporchi, ma con un codice. Ed è proprio Banner a ricordarci che, alla fine, la parola data è l’ultima cosa che resta alle persone come loro. Uomini duri, spietati, ma ancora capaci di riconoscere un frammento di onore in mezzo alla carneficina.
1923: echi dopo l’ultima pallottola
Alla fine, tutto è compiuto. Il male è stato punito ma non redento. I Dutton sopravvivono, ma non vincono. La tenuta è salva, ma a un costo che sfigura qualsiasi concetto di giustizia o di trionfo.
Resta un paesaggio emotivo devastato, un presente ferito che somiglia più a una distesa di macerie che a una promessa di futuro. E tra queste rovine, si aggira un interrogativo non da poco: da dove viene davvero John III? La genealogia si fa volutamente opaca, come se Taylor Sheridan tenesse in mano un mazzo di timeline da rimescolare a piacimento. Non c’è chiarezza, e forse nemmeno volontà di offrirla. O forse si prospetta l’ennesimo capitolo prima di arrivare a Yellowstone?
Ma se la serie ci lascia col dubbio sulla discendenza, non lo fa sulla direzione emotiva. 1923 è un’opera finita, chiusa, coerente nel suo respiro tragico. Una storia che non consola, che non addolcisce. Ma che afferra. E che rimane.
Perché nella sua violenza, nella sua mestizia senza catarsi, conserva una qualità rara: la sincerità. Imperfetta, certo. A volte improbabile nei suoi incastri narrativi. Ma visceralmente vera nel modo in cui mette in scena la fine di un’epoca, la disgregazione di un mito, la resistenza, disperata, di un’identità.
È una lunga storia. Di quelle memorabili.
E continuerà a risuonare, come un colpo a salve nella coscienza dello spettatore. Un’eco che non svanisce, ma che scava.
Gianpaolo Torchio