Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
Boris ha un grande, grandissimo pregio. È ciò che la rende non solo la migliore serie comedy italiana ma qualcosa di unico al mondo. Di dramedy ce ne sono state tante. Da Scrubs fino ad arrivare a quel gioiello di After Life di Ricky Gervais l’ironia ha saputo evolvere in qualcosa di sempre più profondo, vero e a tratti estremamente toccante. Chi non ricorda il drammatico conto alla rovescia che precede in How I Met Your Mother l’annuncio del lutto di Marshall? E l’illusione del Dr. Cox che precede l’improvvisa, devastante presa di consapevolezza mentre in sottofondo si fanno acute le parole di JD “Dove pensa che siamo“?
Abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo immedesimati. Eppure, Boris fa qualcosa in più, fa qualcosa di unico, insuperabile, geniale. È il “sugo”, per dirla alla Manzoni, di Boris, la sua essenza, la non-morale che attraversa tutta la serie. Il comico non si mescola semplicemente al serio ma lo fa con quell’umorismo di cui Pirandello ha dato perfetta definizione. L’umorismo inteso come “sentimento del contrario”, risata che non si ferma alla risata ma che evolve in qualcosa che non ci permette “più di riderne come prima“, perché “La riflessione, lavorando in me, […] mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario“. In Boris non avvertiamo semplicemente il mondo capovolto tipico di qualunque espediente comico.
Noi sentiamo il contrario, lo sentiamo vicino, vicinissimo.
Ce lo fanno sentire alla perfezione gli autori, lo fa alla perfezione quel grandioso protagonista che è Pietro Sermonti nel ruolo di Stanis. Capovolge consapevolmente la sua maschera, fa il verso a quell’attore-dottore che era stato davvero in Un medico in famiglia. Lo scimmiotta. E ne ridiamo per questo. Ma nello stesso tempo lui e noi con lui avvertiamo il sentimento del contrario. La triste consapevolezza della tragicità di un attore narcisista e di una parte stereotipata e convenzionale di medico da fiction italiana. Fa il verso al se stesso uomo e alla sua parte attoriale e ne esce catarticamente, ridendone e piangendone. Cogliendo le proprie debolezze e tutta l’insensatezza tragica del mondo delle fiction, tra attori tronfi e sceneggiature carenti.
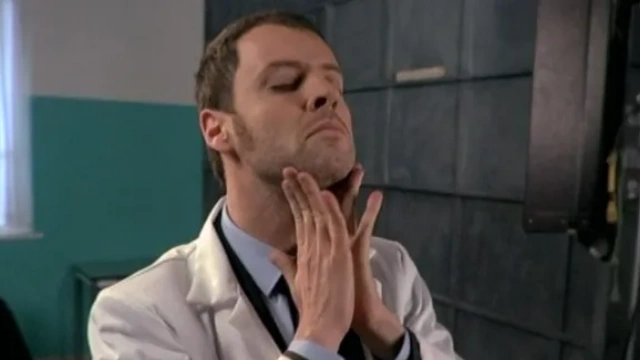
Boris questo sentimento del contrario, questo umorismo totalizzante, lo eleva a proprio credo, lo effonde come spirito in ogni episodio, in ogni scena. Fino a raggiungere un suo tragico ma concretissimo picco nella scena di René e Cristina. Siamo nel decimo episodio della seconda stagione. Nelle puntate precedenti è stato introdotto il personaggio della figlia di Mazinga, vale a dire la figlia dell’oca bianca, di un pezzo grosso. Un’intoccabile, una raccomandata. Eppure Cristina ha qualità, bravura e su di sé pure porta il peso di questo nome, di questa sua sacralità inviolabile. Perché chi è sacro, per etimologia, è sacer, maledetto. Non può vivere, non può entrare in reale contatto con gli altri, non può essere parte della comunità. Vive in un mondo a parte.
Così è Cristina, brava ma maledetta, viziata e fuori dalla realtà.
Nel suo mondo non c’è, apparentemente, difficoltà, angoscia, duro lavoro e peso del vivere. Eppure, ce ne accorgiamo fin dai primi momenti, non c’è neppure, se non superficialmente, leggerezza. La comparsa del personaggio nella 2×09 viene preceduta, non a caso, da questo stigma, quello di essere “a’ fija de’ Mazinga” (uno dei termini chiave nel dizionario di Boris). Prima ancora di far apparire Cristina, viene messa in scena l’opinione che gli altri (in questo caso l’aiuto regista Alfredo) hanno di lei.

Nel contempo in Cristina si coglie la consapevolezza di questa esclusione, del peso della lettera scarlatta che vede tatuata a fuoco su di sé. Non solo. La ragazza in breve scopre un mondo che nella sua campana di vetro non aveva contezza esistesse. Scopre le brutture del dietro le quinte, i mezzucci usati per tirare a campare, l’arrivismo e l’invidia, la meschinità e la pochezza. Per lei è un orrore difficile da metabolizzare. Il primo, in questo senso, a costringerla ad aprire gli occhi è Biascica che, come al solito, senza mezzi termini le sbatte in faccia la realtà:
A me nun me ne frega ‘n ca**o che sei ‘a fija de Mazinga perché io me svejo a matina ae cinque e c’ho i pupi e devo venì qua e già nun me va. Poi arrivamo qua sul set e dovemo aspettà a te. E per me questo è ‘n’atteggiamento demmer*a…
Paradossalmente Biascica è il contatto più umano che Cristina ha, la prima persona che guarda oltre all’apparenza e la tratta da ragazza qualunque, da lavoratrice qualunque, con i suoi obblighi e responsabilità. Boris ci ha già anticipato qui quello che sarà ironicamente uno dei momenti più tragici della televisione italiana. Lo fa con la solita buffoneria, affidando a uno spiazzato e stereotipato Biascica la parola. (Biascica che nel frattempo nella seconda stagione, con la sua crisi interiore, s’è fatto a sua volta parodia dell’approfondimento psicologico e della personalità complessa dei personaggi moderni).
Ma è soltanto nell’episodio successivo che i nodi della trama magistralmente tessuta dagli autori di Boris raggiungono il pettine.
L’esasperazione di René, a un passo dall’essere fatto fuori col progetto irrealizzabile del Machiavelli, si scontra con quella di Cristina, incapace di accettare l’ipocrisia della televisione italiana. Non vuole piangere, non perché non sappia farlo a comando, ma perché lo trova posticcio, insensato, macchiettistico all’interno della scena che deve girare. Non reale. Due mentalità entrano così in rotta di collisione. E attenzione ad abbracciare l’una più che l’altra. Perché se René rappresenta la concretezza quasi donabbondiana di chi tira a campare, di chi non può permettersi di dire no, Cristina è la rabbiosa rivolta giovanile, alla Renzo, di chi non accetta le cose come stanno.

Il discorso di René è il discorso dell’uomo comune, di chi anno dopo anno non ha potuto far altro che chinare la testa per sopravvivere, per andare avanti.
Io ho quasi cinquant’anni, ho la casa sfondata, questo non sarebbe grave però, eh… La cosa grave è che qui mi stanno facendo fuori, hai capito? Io presto dovrò reinventarmi tutto e credimi che a cinquant’anni non è facile. Tu sei una ragazza giovane, tu prendi duecentomila euro per sei mesi di lavoro, quando c’è gente che per mille euro al mese sfonda le strade col martello pneumatico senza battere ciglio e lotta per vivere una vita di merda. Io penso che sarebbe bello per una volta veder le cose nella giusta ottica, no? E fare semplicemente il proprio dovere senza capricci, senza problemi e in questo caso piangendo, se è il caso di piangere.
Ecco la comicità che si fa umorismo, l’umorismo che si fa tragedia. Così la concretezza raffazzonata che per interi episodi è stato il mantra di René, che ci ha fatto ridere al grido di “A ca**o di cane” e “Smarmella tutto” con girati un tanto al chilo, svela la maschera tragica. René è un uomo di mezza età che tira a campare, che vive la difficoltà di portare a casa la giornata, che ha visto infrangere ideali, se mai ne ha avuti, da regista di belle speranze. Un uomo rassegnato che deve guardare in faccia la realtà.
Di colpo la comicità è diventata umorismo, sentimento chiaro, distinto, palese del contrario. L’umorismo s’è fatto tragedia e la risata ghigno.
René ha dalla sua tante ragioni, quelle concrete di chi non può permettersi capricci e neanche lotte ideologiche. Le ragioni di quei tanti che nella nostra società non hanno la forza, anzi non possono, alzare la testa. La vita vera è dura e ingiusta e, forse, chi fa i picchetti per le strade è solo un privilegiato che può permetterselo. Boris anticipa uno scontro culturale che di lì a pochi anni avrebbe investito la nostra società. Anticipa quelle culture wars tra ambientalisti stesi in autostrada e lavoratori nel traffico, tra ecologisti della moda ecosostenibile e persone che cercano affannosamente un capo d’abbigliamento a basso costo che basso, per tante ragioni, non è. È la lotta con influencer che cavalcano i temi dell’integrazione e della parità su yacht e jet privati usati come giocattoli.

Ma spesso, proprio come nel tragico scontro tra René e Cristina, una parte giusta, a ben guardare non c’è. Rimane solo lo scontro, la violenza, lo schiaffo sconvolgente (e probabilmente impossibile oggi da mettere in scena) che René dà a Cristina. È una scena scioccante che gli autori di Boris provvedono a disinnescare rapidamente con un comico primo piano della ragazza che carica una testata contro René e con il sottofondo musicale dei momenti di leggerezza.
Ma è una scena che rimane.
Rimane in tutta la sua tragicità, in quello scontro di valori e di ragioni senza possibilità di soluzione. Nell’urto tra la ragion di stato del Machiavelli di René e lo snobismo ideologico della figlia di Mazinga. E questa cosa la troviamo solo in Boris. Perché se tante comedy hanno pensato a inserire l’elemento emotivo per farsi dramedy solo Boris ha aggiunto la tragica componente sociale nell’analisi della realtà, nell’analisi dell'”Italia del futuro: un paese di musichette mentre fuori c’è la morte“. E questo in fondo è Boris stessa: una serie tv di musichette con tutto attorno la tragica e spesso rassegnata consapevolezza della morte. Ed è il motivo per cui l’abbiamo amata ieri, l’amiamo oggi e, statene certi, l’ameremo anche domani.







