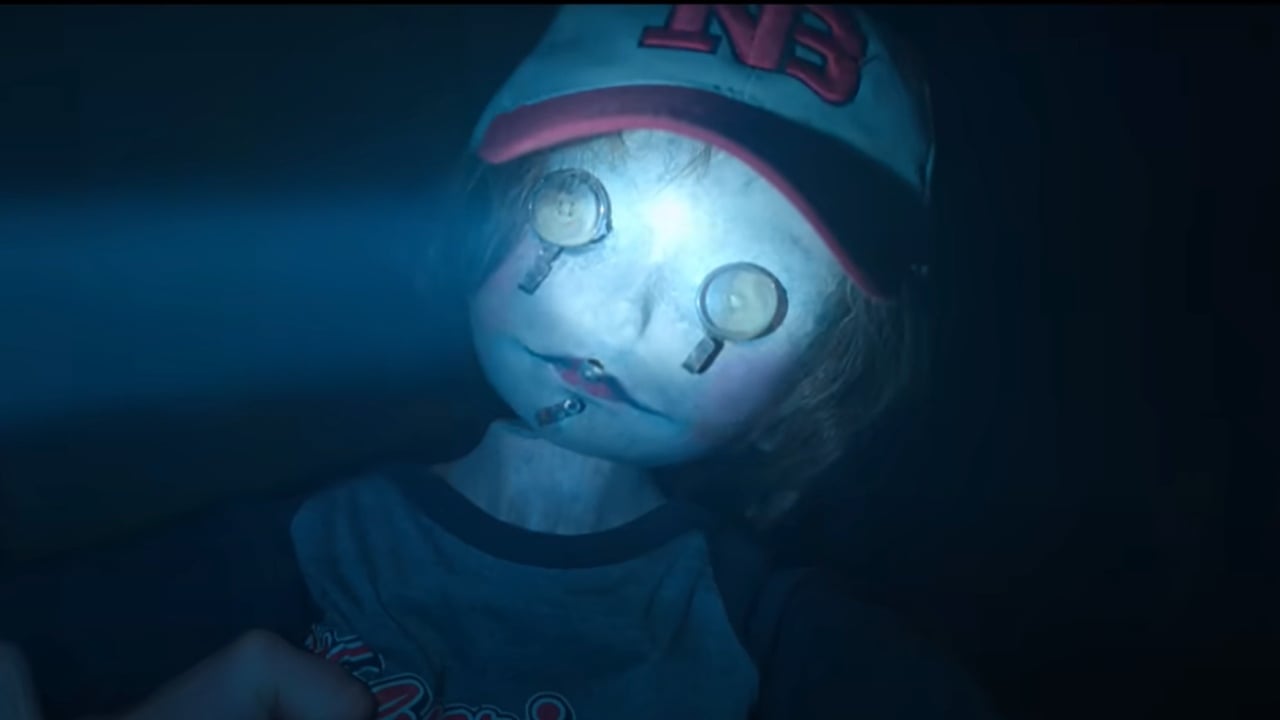Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
Non lo conoscevo, Francesco Nuti. Non lo conoscevo affatto. Conoscevo, vagamente, solo il suo nome: un nome pesante, l’impronta approssimativa dell’artista che fu, i soliti titoli, i soliti cenni biografici, la crudeltà di un destino che si impegnò a fondo per devastarlo pezzo dopo pezzo e ingabbiarlo nella prigione di un tempo sadicamente sospeso. Era un ricordo sbiadito, Francesco Nuti: ricorrente, eppure inconsistente. Dimenticato, quasi da tutti. La sua morte, avvenuta un mese fa, ha però sbloccato qualcosa in me: mi ha fatto venire voglia di incontrarlo una volta per tutte, dopo aver rimandato l’appuntamento per troppo tempo. Scoprirlo, viverlo, farne in qualche modo una parte di me e delle mie esperienze. Scoprire quanto fosse bello, quando la gioventù lo baciava sulla fronte per restituirlo sempre più forte e sempre più fragile: sempre diverso, eppure sempre uguale. E rispondere così a una domanda che troppo spesso mi ero fatto: com’è possibile che un artista capace di dominare per una decade il nostro cinema da primattore assoluto, tanto da averlo portarlo ad anteporsi a tanti dei mostri sacri della sua generazione, sia stato messo in un angolo e cancellato dai ricordi collettivi? Aveva fatto qualcosa di male, Francesco Nuti? Perché tutti avevano deciso, a un certo punto, di girarsi dall’altra parte dopo averlo chiuso in un cassetto, manco fosse diventato un oggettino obsoleto? Dava fastidio? E se sì, a chi?
Quelle risposte, alla fine, non le ho avute. O meglio: forse sì, ma dovremmo entrare nel campo delle speculazioni per avventurarci fino in fondo in un terreno scivoloso che tutto sommato non renderebbe giustizia alla statura di Francesco Nuti. Non se lo facessi io, almeno. Chi sono io, per assumere un ruolo del genere?
So soltanto che non lo meritassimo uno come lui, visto il trattamento subito nel momento in cui non ha più avuto la possibilità di esprimersi al meglio. Non meritavamo il suo amore, la sua sensibilità, la sua intensità. La sua capacità di osare e sfidare i suoi stessi confini creativi per trovare sempre una strada nuova, alternativa. Unica. Non meritavamo quel sorriso beffardo che ne incarnava una toscanità vera, viscerale: spontaneo e profondo, al di là di ogni potenziale impalcatura. Non la sua dolcezza fanciullesca, tenera e incantata, incarnata da anarchici ricci che ne fanno una descrizione più che appropriata. E nemmeno la sua asprezza disincantata spesso celata dietro gli occhiali scuri, nel momento in cui il nostro Paese aveva preso la rincorsa per lasciarlo alle spalle e rimpiazzarlo con chissà chi. Non il suo essere artista, nell’animo. Un artista a cui il successo del divo non bastava mai: non era mai abbastanza per placare l’inquietudine che albergava in uno spirito che danzava surreale tra la commedia e il dramma, in un filo sospeso su un burrone intangibile. Non il suo genio, spesso normalizzato dall’apparente semplicità con cui si approcciava alla poesia, al cantautorato, alla recitazione e alla regia: una regia fatta con mestiere, sapienza e originale visione, senza mai fermarsi al compitino di un autore prestato a un linguaggio che pareva non esser suo solo agli occhi più disattenti.
No, non ce lo meritavamo Francesco Nuti. Eppure abbiamo la fortuna di poterlo riscoprire, pur colpevolmente oltre i confini della sua sfortunata vita. Come ho fatto io nelle ultime settimane, attraverso un viaggio pieno di entusiasmo che mi ha finalmente fatto capire chi fosse, il dio caduto del nostro cinema.

Il percorso artistico di Francesco Nuti, del vero Francesco Nuti che aveva abbracciato l’Italia in una fiammata irruenta ma leggera, carismatica ma timida, è unico e accidentato. Lineare e allo stesso tempo ostinato nella sua discontinuità. Ricorda, almeno a tratti, il cammino che intraprese Claude Monet con la sua musa, la Cattedrale di Rouen, dipinta ossessivamente dall’artista per la bellezza di trentuno volte in due anni: lo fece per catturare prospettive differenti e le imprevedibili evoluzioni della luce riflessa dal suo portale. Si ripeteva, Monet, ma nel farlo raccontava sempre qualcosa di nuovo con un inedito impulso emotivo e un’affinata capacità espressiva. Ecco: Francesco Nuti, in parte del suo percorso, fece qualcosa di simile. Tese alla ripetizione, specie nel racconto di certe dinamiche di coppia, non per mancanza d’ispirazione, bensì per riscoprire le sue storie e le sue maschere all’interno di contesti e situazioni differenti, raccontando in questo modo un cammino tumultuoso in cui il soggetto non era il mondo, seppure l’avesse tratteggiato nel chiaroscuro della sua transizione attraverso prospettive interessanti: non il nostro Paese, non una visione universale né la ricerca di un mezzo per insegnare qualcosa a qualcun altro. No, affatto. I film di Francesco Nuti, dal primo all’ultimo, rappresentano un’estrema ricerca di se stesso, della propria individualità, delle storie vissute e di una visione del mondo a cui dare forma, bellezza e raccordi, attraverso un filo conduttore che ne definisce l’impossibile catalogazione all’interno di schermi predefiniti: la solitudine, adombrata dalla costante dell’abbandono.
Ci si ritrovava quindi per un’infinità di volte col solito cast e gli stessi collaboratori imprescindibili in una vita dai rari riferimenti, tra una lunga sequenza di sigarette e svariati bicchieri di troppo, dentro uno dei grandi amori della sua vita: il tavolo da biliardo, accarezzato da una stecca in alluminio a cui offrire tutto l’amore possibile sul solco di geometrie nostalgiche che restituivano una qualche forma di razionalità alla vorace volontà di aggredire il presente. Mentre ognuno dei suoi personaggi, alter ego impossibili di un artista sorprendentemente possibile, attraversavano un decennio abbondante per schiudersi all’interno di narrazioni surreali e passionali, tumultuose e restie all’idea del compromesso, col solo fine di esser torrente impetuoso e lago placido: arrendevole ultimo e vulcanico amante. Immersi in scorci bucolici o urbani avvolgenti, rassicuranti e sensuali, immortalati da soggettive in cui diviene inevitabile aver voglia di addentrarsi totalmente. Paesaggi intensi e leggiadri che si riflettono negli occhi delle sue numerose amanti, cariche di una poetica fuori dal tempo e delle contraddizioni di un decennio confusionario, dipinte con inarrivabile trasporto nelle loro infinite sfumature. Tanto vere da finir poi per uscire più volte dai confini del set.
Francesco Nuti, allora, sembrava voler fare del cinema uno strumento per raccontarsi a fondo e per legare la finzione alla realtà in un bacio destinato ad ardere e a spegnersi poco dopo. Era sempre se stesso al di là di chi interpretava, permettendoci così di conoscerlo a fondo ed esser lì con lui tra centinaia di nuvole passeggere, in un tempo presente costante che supera le regole del nostro essere.

Eccolo allora, Francesco Nuti: un artista da vivere, più che da analizzare. Compreso e apprezzato da chi sapeva empatizzare con lui, più che dai critici miopi che l’avevano vessato in ogni modo. Da scoprire, prima ancora che da capire. E da ritrovare, nelle pellicole migliori quanto in quelle meno riuscite e fortunate: incluso quel maledetto OcchioPinocchio che ne sancì per molti versi la rovina, audace volo pindarico di un sognatore che disconosceva ogni limite. Un sognatore che in ognuna delle sue storie ha dato tutto: persino troppo, in troppi sensi. Avendo in cambio troppo poco, al tramonto dell’effimera gloria. Un sognatore che al di là di ogni possibile valutazione ha offerto un contribuito prezioso alla storia del nostro cinema, tra i successi del primo decennio e la rovinosa caduta dell’uomo che aveva osato senza sapersi accontentare mai, dentro un percorso creativo fervido che riconosce rari eguali nella nostra storia persino nei momenti più bassi.
Eccolo allora, l’artista dimenticato: l’artista che l’Italia ha acclamato per anni e non ha saputo meritare, scomparso in un pomeriggio di metà giugno nell’indifferenza generale tra una manciata di pezzi pretestuosi, sporadici omaggi davvero sentiti e la sostanziale impossibilità di riviverlo in televisione. Una televisione che non aveva saputo valorizzarlo fino in fondo manco nei suoi anni d’oro. Un artista che non ha ottenuto oggi, persino nella stagione dai palinsesti condensati dalle solite replichette, la trasmissione dei suoi film sui palcoscenici più prestigiosi in orari all’altezza del suo nome.
No, non è successo niente di tutto ciò: morto Nuti, viva Nuti. Avanti il prossimo.

Per fortuna, però, esistono altri modi per connettersi con lui, con le sue storie e con la sua arte: come ho fatto io, nelle ultime settimane, in un percorso bellissimo che porta inevitabilmente a un certo senso di vuoto nel momento in cui conclude. A un silenzio, prolungato ben oltre una sola sera: uno di quelli in cui lui dava il meglio di sé. Restano il silenzio e dei titoli di coda che avremmo voluto interrompere, col rimpianto per quello che avremmo potuto vivere e la gioia per quello che si è vissuto attraverso uno schermo. Anche a posteriori, con rinnovato trasporto.
No. Non ce lo meritavamo, l’animo malinconico e burrascoso di Francesco Nuti. Ma per fortuna possiamo ancora fare qualcosa per rimediare, almeno in minima parte. E per riscoprire, in un mondo non più suo, una mente creativa che avrebbe meritato un trattamento ben diverso. Degno dei più grandi, degno di un amico fragile. Se vorremo, allora, lo ritroveremo a ovest di Paperino in una notte genovese venuta da lontano, per fare una passeggiata tra le cime del Paradiso in groppa a uno stambecco bianco. Nelle oniriche strade di Casablanca, sulla falsariga dello Scuro, con una stecca in mano e un nuovo amore dietro l’angolo. L’amico fragile, conosciuto troppo tardi, sarà sempre lì ad attendere i pochi che avranno la giusta sensibilità per meritare uno come lui. E avrà stampato sul viso un sorriso dolcissimo.
Antonio Casu