Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
Tutti abbiamo vissuto quella spiacevole situazione raccontata brillantemente da Zerocalcare in Strappare lungo i bordi: chi non è mai stato ore a scorrere i film sulle piatteforme streaming e non trovare niente da vedere pur avendo a disposizione “tutto l’audiovisivo del mondo” e pensando “è possibile che son tutti film de m*rda”? Certo, la roba bella magari l’abbiamo già vista, altra siamo in ritardo e altra ancora la teniamo per il momento giusto – se arriverà. Vogliamo evitare, però, di finire nella fantascienza polacca del ‘900 in lingua originale, andare a letto frustrati con la nostra coscienza sottoforma di Armadillo che ci costringe a interrogarci su noi stessi dicendo: “Dai su, se su ottomila film non te ne va bene manco uno, forse sei te che non vai bene”. Proprio per questo nasce la seguente rubrica settimanale, in onda ogni lunedì e rivolta sia a chi la pellicola in questione non l’ha mai vista, sia a chi l’ha già visionata e vuole saperne di più: infatti, nella prima breve parte vi consigliamo un film; nella seconda invece ve lo recensiamo, analizziamo o ci concentreremo su un aspetto particolare. E questa settimana abbiamo scelto American Psycho.
PRIMA PARTE: Perché, dunque, vedere American Psycho? Ecco la risposta senza spoiler.
Tratto dall’omonimo romanzo del 1991, American Psycho – disponibile su Netflix, Timvision e Starz (a noleggio su Amazon Prime Video e Apple Tv) – fece discutere nel lontano 2000 per la violenza e i temi sociali trattati, tutt’ora attuali. Patrick Bateman è l’essenza del film e l’immagine della Wall Street di fine anni ’80. E non solo. È bello, statuario, ossessionato dalla cura per il corpo, freddo e asettico come il suo appartamento; vive nel lusso, indossa vestiti di marca, frequenta i locali più in e le donne più belle della città. Di notte, però, libera il mostro dentro di lui, che trova piacere nella tortura e nell’omicidio.
Un personaggio iconico della storia del cinema, che continua a ispirarne tanti pure a livello televisivo (da Dexter che dà il nome alla sua serie a Nate di Euphoria), grazie all’interpretazione stratosferica di Christian Bale, lanciandolo definitivamente nell’olimpo di Hollywood. Non solo mostra le sue incredibili capacità trasformistiche (con diete e allenamenti rigorosi raggiunse il fisco palestrato di Bateman), ma si cala perfettamente nelle due personalità dell’uomo, riuscendo a tramettere tantissimo in ogni singola espressione, gesto e movimento.
Mentre attorno a lui si sviluppano personaggi secondari con destini diversi, la pellicola si addentra nella sua psiche sempre più folle, in un viaggio all’inferno dove tensione e black humor si bilanciano con scene che contemporaneamente inorridiscono, divertono e fanno riflettere. American Psycho cattura il pubblico con una storia accattivante, a tratti parodistica, che lo rende partecipe dei pensieri – grazie al voice over – e delle azioni di Bateman, anche e soprattutto dei suoi omicidi e della loro preparazione. Può essere tecnicamente invecchiato male, ma è un cult imprevedibile che trova in questo (e nella recitazione di Bale) la sua forza; un esperimento che ancora oggi affascina, ripugna e fa parlare di sé. E per un’analisi accurata di questo thriller psicologico vi invitiamo, una volta visto il film, a leggere la seconda avvincente parte dell’articolo.
SECONDA PARTE: L’analisi con spoiler di American Psycho e del suo finale
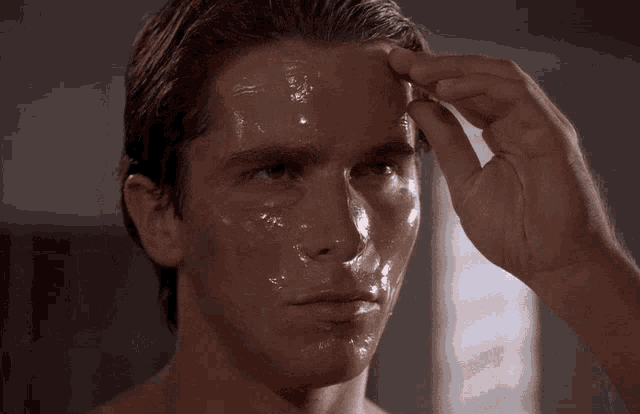
“Ho tutte le caratteristiche di un essere umano: carne, sangue, pelle e capelli. Ma non un solo, chiaro e identificabile sentimento, a parte l’avidità e il disgusto.”
Basterebbero queste parole di Bateman per riassumere American Psycho. Una critica verso i valori che l’élite americana da lui rappresentata incarna: consumismo sfrenato, immagine, ipocrisia, avidità, cieco individualismo e assenza di morale. Estremizzandone la cultura fatta di arrivismo, gelosie e antagonismo, viene svuotata e ridicolizzata. Quei broker vogliono primeggiare e affermare sé stessi, perdendosi però nei meandri dell’omologazione, con le diverse identità che si fondono in quell’élite in cui ognuno pensa illusoriamente di essere speciale. La distruzione dell’io crea un vuoto esistenziale che depersonalizza e deumanizza l’altro, facendo così uscire i peggiori impulsi e rendendo incapaci di instaurare legami autentici. Si crea un gioco di specchi in cui nessuno si conosce seriamente e dove la fantasia diviene più reale della realtà stessa: Bateman, infatti, vive in una dimensione parallela costituita dai suoi omicidi e dalle sue vittime.
Il protagonista incarna così un moderno Dorian Gray che cela la sua depravazione dietro un’ingannevole maschera di bellezza, ottenuta attraverso un’ossessiva e malsana cura del fisico. Ostenta poi tutto ciò che dimostra la sua estrazione sociale, ad esempio i bicchieri di cristallo in cui beve scotch costosissimi o la scrivania di mogano su cui appoggiare le sue scarpe Ferragamo. Non avendo veri sentimenti, ribalta l’importanza degli eventi trasformando il banale in importante e viceversa. I biglietti da visita ne sono l’emblema: non solo i personaggi ne discutono come se stessero parlando di un’opera di Michelangelo, ma, quando Bateman perde contro Paul Allen, prova una rabbia e un’invidia incontenibile.
A mettere ulteriormente in risalto questa critica c’è la scelta del cast, in cui si vede il contrasto tra essenza e apparenza. L’élite americana ha esemplari bellissimi in Christian Bale, Jared Leto, Reese Witherspoon, Justin Theroux e via dicendo. L’unico personaggio positivo, invece, ha il volto di colui che sa incarnare la pazzia come pochi altri, ovvero Willem Dafoe. E la città, poi, funge da cornice quasi irreale, sia per le riprese esterne, sia per gli scorci fatti dalle finestre di case e uffici dei ricchi intermediari finanziari. La povertà e la paura dell’HIV viene così nascosta dietro il lusso, belle donne bionde sotto antidepressivi e uomini-fantocci palestrati dall’abbronzatura impeccabile.

Nessuno, infatti, immagina che uno come Bateman sia un assassino, figuriamoci della peggior specie: quelli che uccidono per il gusto di farlo, senza un motivo. Lui stesso, narcisista patologico, ammette di indossare un costume, esemplificato dalla maschera per il viso che si toglie nella sua routine mattutina.
Ma c’è molto di più in Bateman della sua psicopatia.
È immerso in un contesto competitivo dove lui e i colleghi si contendono il primato non solo mettendo in discussione la mascolinità degli altri, ma anche denigrando tutti coloro che non appartengono alle categorie “uomini, eterosessuali, bianchi, ricchi”. Incarnano l’ipermascolinità tossica che sfocia nell’omoerotismo. Bateman, infatti, confronta costantemente e feticisticamente il suo corpo e il suo status con quello di altri uomini, umiliandosi quando non ne è all’altezza come col biglietto da visita. In lui emerge da un lato il bisogno di controllo e di dominio, tradotto dai suoi atteggiamenti violenti; dall’altro dei comportamenti che, stereotipicamente, sono ritenuti femminili o espressione di un’omosessualità forse repressa. Perché, pur odiando le donne e trattandole come oggetti intercambiabili, disprezza quei loro tratti che lui stesso possiede e ciò suggerisce che la sua misoginia derivi dal senso d’inadeguatezza: infatti, pur sforzandosi visibilmente, non riesce né a inserirsi tra i suoi colleghi, né a ottenere il rispetto che desidera.
Ecco che se la prende con i socialmente inferiori per nutrire il suo ego oppure con chi vorrebbe essere, ovvero Allen.
Bateman è sé stesso solo quando è un killer, poiché con le sue vittime non deve fingere e sfoga la sua natura soppressa attraverso la sua psicosi. Vengono a galla le sue perversioni, ma anche confessioni inaspettate, come l’ammirazione per Whitney Houston, il racconto dell’evoluzione dei Genesis e il suo apprezzamento per la cultura popolare: una contrapposizione musica pop e violenza che non solo ricorda Kubrick e Scorsese, ma che, proprio come loro, potrebbe suggerire in modo sovversivo che la personalità sociopatica di Bateman è il prodotto diretto della cultura mainstream americana.

Così, mentre il film si tuffa sempre di più nella psiche di Bateman, la realtà diventa sfumata sia per lui che per il pubblico, arrivando al finale di American Psycho che necessita un’approfondimento.
Ci sono due interpretazioni a riguardo.
La prima è che Bateman non sia un’omicida, sostenuta da vari elementi: in primis, gli eventi surreali del bancomat che chiede di essere nutrito con un gatto randagio e dell’inseguimento con la polizia in cui lui riesce a far saltare la loro macchina con pochi colpi di pistola. In secondo luogo, Allen sembra vivo per diverse ragioni: l’avvocato che dice di aver pranzato con lui pochi giorni prima; la presenza di Bateman a una cena con i colleghi la sera dell’omicidio; non viene mai apertamente detto che è morto, né mostrato il suo cadavere; Bateman potrebbe aver saputo del viaggio di Allen a Londra direttamente da un messaggio sulla segreteria di quest’ultimo e aver poi costruito sopra la propria delirante versione degli avvenimenti.
Del resto, il protagonista ha fantasie violente in American Psycho, messe su carta nei disegni rinvenuti dalla sua segretaria. Quindi potrebbe semplicemente aver immaginato di uccidere Allen e la sua confessione rappresenterebbe la presa di coscienza delle sue allucinazioni che, così, potrebbero concludersi e lui trovare pace.
In questo modo, però, il finale non solo sarebbe un happy ending sorprendente, ma risulterebbe debole e insensato. Anche perché ci sono diverse scene reali che testimoniano la sua furia omicida, come le lenzuola sporche di sangue, l’omicidio del barbone in stile Arancia Meccanica e le torture alle prostitute. Molte delle questioni menzionate sono poi facilmente spiegabili seguendo questa seconda teoria: dato che sono tutti concentrati su sé stessi e nessuno si interessa al prossimo, ci potrebbero essere stati scambi di persona. E il cadavere di Allen non si trova semplicemente perché Bateman l’ha fatto a pezzi. Senza contare che l’appartamento della vittima viene pulito e liberato dai corpi, senza avvertire la polizia, perché uno prestigioso come quello deve essere immediatamente rimesso sul mercato, come la società che American Psycho critica vuole: è evidente quando l’agente, per evitare problemi, caccia Bateman dopo che capisce che lui è coinvolto in quanto era successo lì dentro.
Allora quei momenti irreali del bancomat e della sparatoria dimostrano che Bateman non riesce più a distinguere la realtà dalla fantasia. Di conseguenza, lui è davvero colpevole degli omicidi, ma nessuno ne è interessato o gli crede.
E allora il suo finale è tragico in American Psycho.
Confessando i suoi peccati, Bateman si sarebbe finalmente liberato perché tutti avrebbero saputo chi era davvero. Così, invece, rimarrà sempre insignificante pur sapendo di non potersi omologare e quindi costretto a fingere costantemente. Non potrà conoscere sé stesso perché non ha la punizione che merita e dunque non soddisferà mai la sua sete di sangue. Ogni possibilità di redenzione (o meglio, di catarsi) scompare poiché, non potendo commettere crimini, non può pentirsene e, anche se li facesse, sarà come se non avessero mai avuto luogo. Chiuso in un purgatorio dantesco senza fine, la sua confessione non è una via d’uscita, “non ha nessun significato”.
Anche quando sta occultando il cadavere, il collega che lo ferma è più interessato alla marca della borsa piuttosto che al suo contenuto sospetto. Insomma, ogni volta che prova a uscire dal sistema, Bateman viene riassimilato a esso nel posto che gli altri hanno deciso per lui. Facendo perdere valore alla realtà e intrappolandolo – con gli altri – nel suo personale incubo.
A chiudere la questione – e questo pezzo – è intervenuta infine la regista di American Psycho, una delusa Mary Harron:
“Penso che sia un fallimento che le persone guardino il film e pensano che sia tutto un sogno. Non l’ho mai voluto. Tutto quello che volevo era che il film fosse ambiguo nel modo in cui è stato il libro. Penso che il finale rappresenti un mio fallimento. Avrei dovuto lasciarlo più aperto. Fa sembrare che fosse tutto nella sua testa, e per quanto mi riguarda non è così”.







