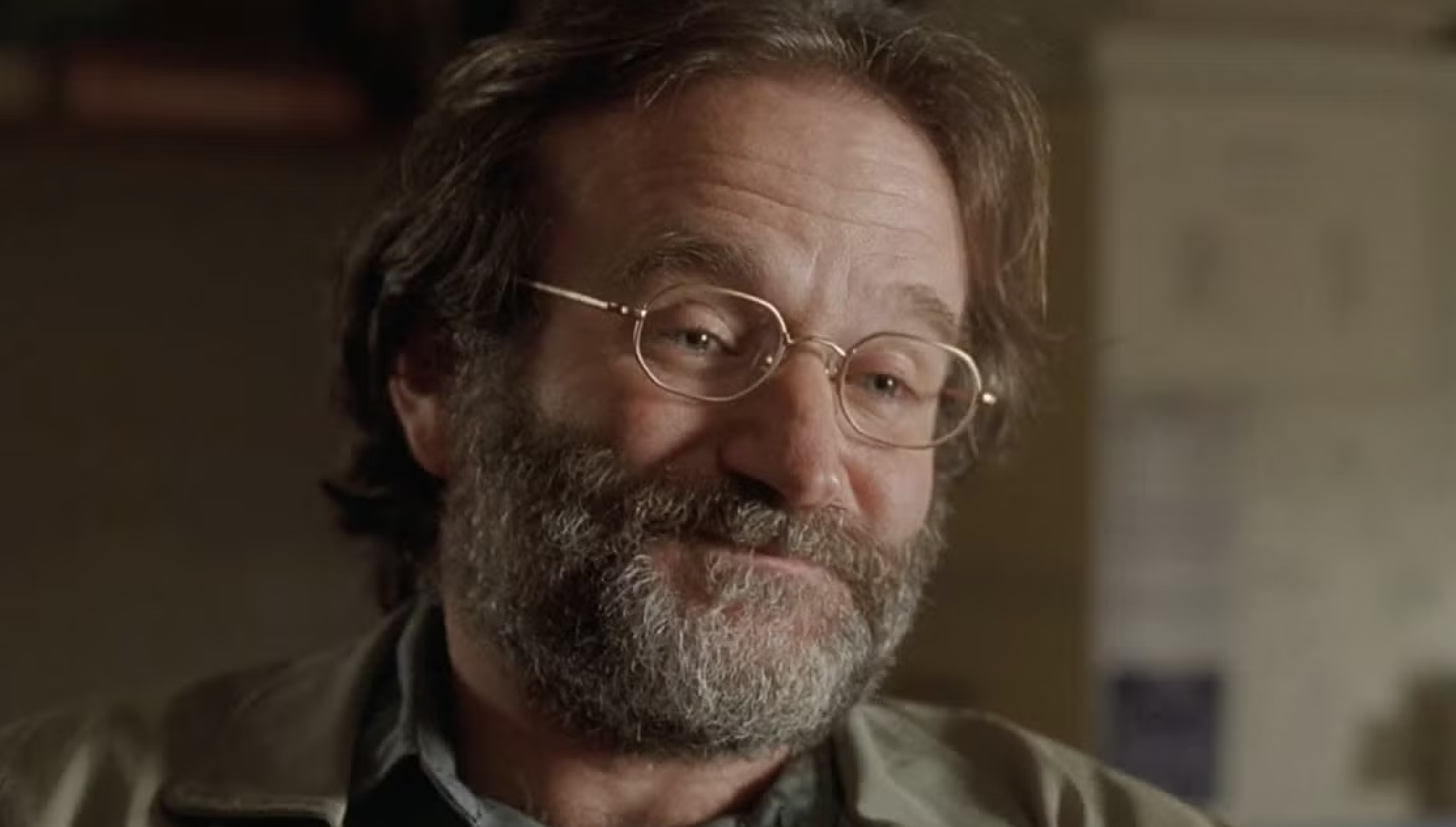Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
Una variegata e anche un po’ strana collezione di cappelli. La festa di compleanno di un bambino, ricca di regali incredibili ma priva di coetanei. Un ambiente strano, una sorta di oasi naturale piena di animali con un albero in una stanza. Un ambiente tanto grande, troppo grande per la quantità di persone che lo vivono. Potrebbero essere tre elementi in apparenza randomici, senza nessun tipo di connessione l’uno con l’altro, invece sono i primi che ci troviamo davanti cominciando Il bambino che collezionava parole, produzione originale Netflix messicana disponibile da mercoledì 1 maggio in piattaforma.
Diretto da Manolo Caro – che nel 2018 è stato regista di Perfectos Desconocidos, rifacimento del nostrano film di Paolo Genovese -, Il bambino che collezionava parole è tratto dall’omonimo romanzo di Juan Pablo Villalobos. Un libro che, rispetto al film, forse riesce a rendere meglio la complessità d’animo e di vita del protagonista, Tochtli. La pellicola fonde una storia profondamente triste e problematica a uno stile che non la rispecchia pienamente, ma la rende più digeribile. È un bene? Io vi dirò la mia, ma lascio poi a voi giudicare. Per farlo, però, bisogna partire dall’inizio: dai cappelli, dalla festa e dalla casa con le quali abbiamo cominciato.
Il bambino che collezionava parole: la trama
Tochtli è un bambino sveglio e curioso, con la testa perfettamente rasata e un cappello perennemente in testa. Che sia un sombrero, un kasa da samurai o qualunque altro copricapo gli vada a genio in un particolare momento – corona compresa -, poco importa: ce n’è sempre uno. Così come quello del suo compleanno, Tochtli passa tutti i giorni della sua vita nell’enorme casa/zoo/oasi naturale in mezzo al nulla/prigione in cui vive. È circondato da animali in via d’estinzione e non, da poche persone e nessun bambino. È un paradiso e contemporaneamente un inferno in terra perché, per quanto meravigliosa possa sembrare la sua dimora intesa come un luogo d’intrattenimento, si capisce subito che c’è qualcosa che non va.

In realtà ci mettiamo poco anche a capire cos’è: suo padre Yolcaut, colui che tutto sempre può, è il capo di una gang di narcotrafficanti (narcos in Messico, vi ricorda qualcosa?!). Va da sé che tutti coloro che Tochtli frequenta siano i suoi fedelissimi, l’anziana domestica di casa, il tuttofare e pochi altri. Tra questi il maestro, con una visione della vita e del mondo ben diversa da quella del boss, ma anche molto affezionato al bambino.
Tochtli ama studiare, preferisce la storia alla grammatica e sa tutto della Francia e della sua rivoluzione, quasi ossessionato com’è dalla ghigliottina. È un bambino fantasma, protagonista del suo microcosmo ma inesistente fuori. Ma pur vivendo in un mondo molto ridotto, o forse proprio a causa del mondo ridotto in cui vive, gli piace conoscere cose nuove, passione che mette in pratica con l’accurata lettura del dizionario dal quale apprende ogni giorno una parola nuova.
Imparare e collezionare permette a Tochtli di vivere una vita diversa dalla sua. Una vita più piena.
Certo, quella per la lettura e per la storia è una passione, ma è sotto sotto anche un bisogno di evasione. Abituato com’è a conoscere il mondo solo dall’altro lato delle sue quattro mura, il bambino cerca di viverlo come può, imparandone il passato e collezionando animali e cappelli, esemplari di vita e oggetti rappresentativi di culture altre e lontane. Con il maestro che lo guida nella passione per la conoscenza e il padre che, viziandolo a dismisura, gli permette di ottenere tutto ciò che vuole, Tochtli vive una vita parallela alla sua, evadendo con la mente da un ambiente dal quale non gli è permesso uscire.
Questo almeno fino a quando, complice la necessità di un “viaggetto” per uscire per un po’ dai radar, Yolcaut porta suo figlio in Africa per un safari alla ricerca di quella che è la sua principale ossessione: l’ippopotamo pigmeo. Non vuole solo permettere a suo figlio di vederne uno: lui vuole farglielo avere perché, per l’appunto, Yolcaut siempre puede. Il punto però è che in realtà Yolcaut non può sempre, nessuno può sempre. E proprio il viaggio in Africa, teoricamente l’apice delle possibilità offerte al bambino, diventa il primo momento in cui Tochtli si rende conto del fatto che, a differenza di quanto gli è sempre stato insegnato, suo padre non è onnipotente e i membri delle gang mentono. E, dulcis in fundo, le verità possono fare davvero male.

Il folklore senza emozione
Non starò a parlare oltre della trama, perché come recensione e non come riassuntino l’idea è che prima o poi la vediate con i vostri occhi. Sono arrivata quindi alla fase che mi piace meno: quella in cui vi dico che se cercate una storia che vi colpisca nel profondo Il bambino che collezionava parole non è una di queste.
L’idea qui è molto semplice: è innegabile come le vicende raccontate abbiano del potenziale. Un bambino costretto in cattività, un essere umano del quale nessuno al di fuori di una cerchia molto ristretta di persone conosce l’esistenza, è di per sé un elemento interessante. Tochtli guarda il mondo con gli occhi dell’immaginazione molto più di quanto non faccia con quelli della realtà. Ma anche nelle rare occasioni in cui riesce ad avere contatti con il reale sembra quasi non dare peso alla cosa. Curioso com’è, non si fa troppe domande al di fuori di quelle che gli sono concesse. Non si chiede dove sia sua madre, né perché ha conosciuto un bambino con una classe numerosa mentre lui è sempre solo. Forse qualcuno glielo ha spiegato in passato, quando noi non c’eravamo, eppure non fa mai una piega. Si tratta di rassegnazione o di semplice mancanza di profondità?
Quella che ho trovato ne Il bambino che collezionava parole è, purtroppo, una mancanza di equilibrio. Manolo Caro non è riuscito nella missione di raccontare una storia interessante in modo leggero ma approfondito. Il folklore, i canti messicani e lo stile di vita tipico sembrano restare sempre un po’ lì, in superficie, e mai affiancati a elementi che ne facciano comprendere la reale importanza. E in un contesto in cui vediamo arrivare e andare via personaggi un po’ a caso ci poniamo una domanda ben precisa.
Dov’è l’inaspettato?
Sappiamo fin dal primo secondo del film che c’è qualcosa di strano, pur non sapendo cosa. Quando ce ne rendiamo conto – poco dopo a dire il vero – non sussultiamo, non ci chiediamo mai come sia possibile. Non ci sorprendiamo. Gli eventi si susseguono, le cose accadono, e ogni volta la sensazione è quella di sapere già come andrà a finire. Sappiamo fin da subito che il maestro combinerà qualcosa che a Yolcaut non piacerà, così come sappiamo che il viaggio in Africa non può essere un semplice viaggio in Africa. Ma così viene a mancare quell’elemento di sorpresa che, pur non essendo sempre necessario, nel cinema ha la sua importanza.
Non tutti i film sono fatti per essere seguiti con attenzione e pathos, nell’attesa che accada qualcosa di grande. Alcuni film sono semplicemente lì per darci qualcosa senza troppe pretese e credo che Il bambino che collezionava parole rientri in questa seconda categoria. Non è un capolavoro, ma non va nemmeno inserito tra i peggiori film originali di Netflix. E non vi allarmate, non è neanche trash e insulso come Fabbricante di lacrime, che comunque senza saper né leggere né scrivere sta sbancando tutto. Insomma, è uno di quei film che no, non vogliono essere chissà quale incredibile riflessione sulla vita ma sì, ci consegnano una morale.
E quindi qual è la morale di Il bambino che collezionava parole?
Risposta secca: la curiosità ci fa sopravvivere, nessuno è infallibile e l’amore di un genitore arriva ovunque, anche dove non ci aspettiamo che possa raggiungerci.