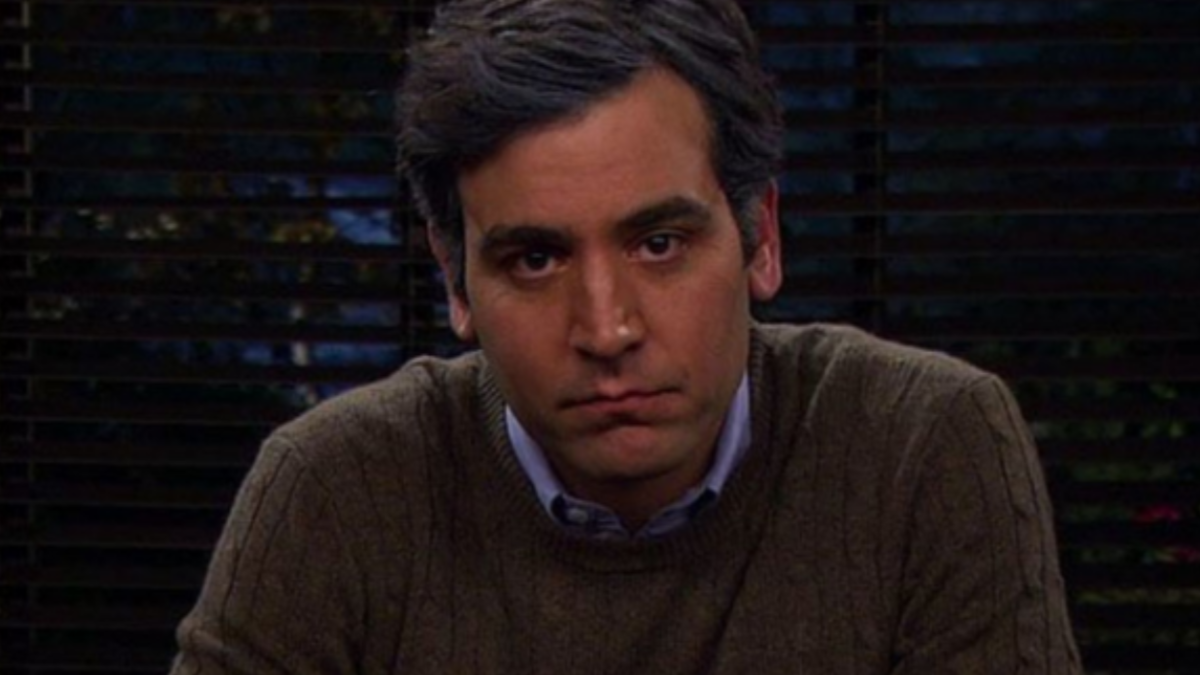Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
Caro diario,
sono io, Clarke.
Ero decisa a impiegare tutti i fogli per il disegno, ma poi ho scelto di utilizzarne alcuni per assemblarti. Sarà che da piccola tenevo un diario segreto e che mi piaceva farne un interlocutore immaginario quando avevo qualcosa da raccontare. In realtà le giornate non erano particolarmente entusiasmanti, sull’Arca, tant’è che finivo spesso a scrivere della Terra al posto di resocontarle. Descrivevo il modo in cui immaginavo gli alberi, i monti, il mare e tutto ciò che ci veniva detto ne calcasse il suolo quando era ancora un luogo ospitale; parlavo della casa che avrei allestito semmai avessimo avuto modo di tornare ad abitarci, dei luoghi che avrei visitato, delle cose che avrei fatto. Di certo quella Clarke non sospettava che un giorno si sarebbe ritrovata a vivere sul pianeta di cui tanto fantasticava totalmente, completamente da sola.
Almeno fino a un certo punto.

Le cose sono decisamente migliorate, da quando c’è Madi. O meglio: sono decisamente migliorate da quando Madi ha smesso di vedermi come una minaccia da neutralizzare. Per fortuna è successo prima che ci rimettessi un braccio; ci sono andata terribilmente vicina, grazie alle simpatiche trappole che aveva disseminato in giro apposta per la sottoscritta. Avrei potuto tenermi lontana nel nome delle mia sicurezza, ma la presenza di un altro essere umano era un miracolo che non potevo ignorare. Ero disposta a mettere a rischio quel braccio pur di interagire con un’altra persona, anche se sono contenta che non sia stato necessario sacrificarlo. Superate le divergenze (ricorro a questo eufemismo in virtù dell’affetto che ho sviluppato nei suoi confronti) iniziali, io e Madi ci siamo costruite una nostra routine: appena sveglie facciamo colazione, poi andiamo alla ricerca di ciò che la terra ha da offrirci, prepariamo il pranzo, facciamo i compiti, accendiamo il fuoco per non finire preda del buio quando il sole tramonta. Le sto insegnando la mia lingua d’origine, le basi del disegno, ciò che ho imparato da Pike. È ricettiva, intelligente e curiosa; un’ottima studentessa con il vizio di sabotare le lezioni di matematica. D’altronde nemmeno a me è mai piaciuta, come materia.
Grazie a Madi, sento di avere di nuovo uno scopo che non sia la mera sopravvivenza. La vita non è soltanto questo e non dovrebbe mai esserlo; è una lezione che ho imparato a mie spese, ma che la solitudine rischiava di farmi dimenticare.

Madi è il centro delle mie giornate, la lancetta che scandisce le mie ore, i miei minuti e i miei secondi. A volte ho quasi l’impressione che occuparmi di lei possa essere abbastanza, ma i ritratti che tengo esposti non mancano mai di ricordarmi che è una bugia.
Anche oggi abbiamo avuto la nostra sessione di storie risalenti all’epoca che ha preceduto il Praimfaya. Quegli anni mi sembrano così lontani da apparirmi come un miraggio, lo scampolo di una vita che è appartenuta a qualcun altro e non a me. Ricordarli mi aiuta a riappropriarmene, in qualche modo; mi aiuta a sentirmi ancora me stessa. Madi mi ascolta con interesse. È strano pensare che quelli che per me sono stati amici, alleati e avversari siano per lei i protagonisti di un racconto, personaggi fittizi che acquistano forma e consistenza solo nelle mie rievocazioni. Mi ha portato a chiedermi cos’avrebbe pensato di me se mi avesse conosciuta non di persona, ma tramite il passato che ho alle spalle e sopra la coscienza; se mi avesse vista non con i suoi occhi, ma attraverso quelli di chi mi ha conosciuta. Non credo di voler conoscere davvero la risposta.
Octavia si conferma la sua preferita. Ha ribadito che non vede l’ora di incontrarla. L’ho riferito a Bellamy, durante quella che mi piace definire, anche se impropriamente, la nostra radiochiamata quotidiana. “Tua sorella ha una fan qui” gli ho detto, e mi è quasi sembrato di vederlo roteare gli occhi verso l’alto, in un gesto di finta esasperazione che mi ha portata a sorridere come se fosse stato realmente compiuto davanti a me. “Ma tutto sommato anche tu gli piaci.”
Per quanto mi fossi ripromessa di non farlo, ho ascoltato il silenzio in attesa di una risposta; non è arrivata. Esattamente come nei milleseicento giorni precedenti.

In fondo è anche per questo che ho scelto di tenere un diario: perché è normale, e non deludente, che le pagine accolgano le tue confidenze restando mute. Forse dovrei interrompere le radiochiamate per evitare di andare a sbattere contro certe aspettative ancora e ancora e ancora, ma non riesco a fare a meno di scontrarmi con questo muro, malgrado l’impatto con il cemento faccia ogni volta più male. Non riesco a smettere di contattare Bellamy e di credere che un giorno, quando meno me lo aspetto, otterrò qualcosa: un rumore, un segnale; una parola. Ho bisogno di credere che i miei amici siano lì da qualche parte. È un pensiero che mi dà conforto e mi addolora allo stesso tempo. Conforto nel saperli vivi e dolore per il fatto che sono distanti anni luce, a vivere una vita di cui non faccio parte. Sono rimasta indietro apposta perché potessero averla, ma evidentemente non sono così altruista da riuscire a farmi bastare il fatto di averli tratti in salvo.
Vorrei che fossero qui, con me; vorrei che Madi potesse associare ai loro nomi volti i cui lineamenti non siano fatti di grafite; vorrei che formassimo una nuova, grande famiglia, tutti insieme. Vorrei ognuna di queste cose, e anche se il tempo che passa le rende sempre più simili a sogni destinati a non realizzarsi, come ha detto Bellamy una volta, se stiamo ancora respirando, vuol dire che c’è speranza.
Ora vado a controllare che quella piccola peste abbia pulito la capanna come aveva promesso di fare.
A domani, caro diario.
Tua Clarke.