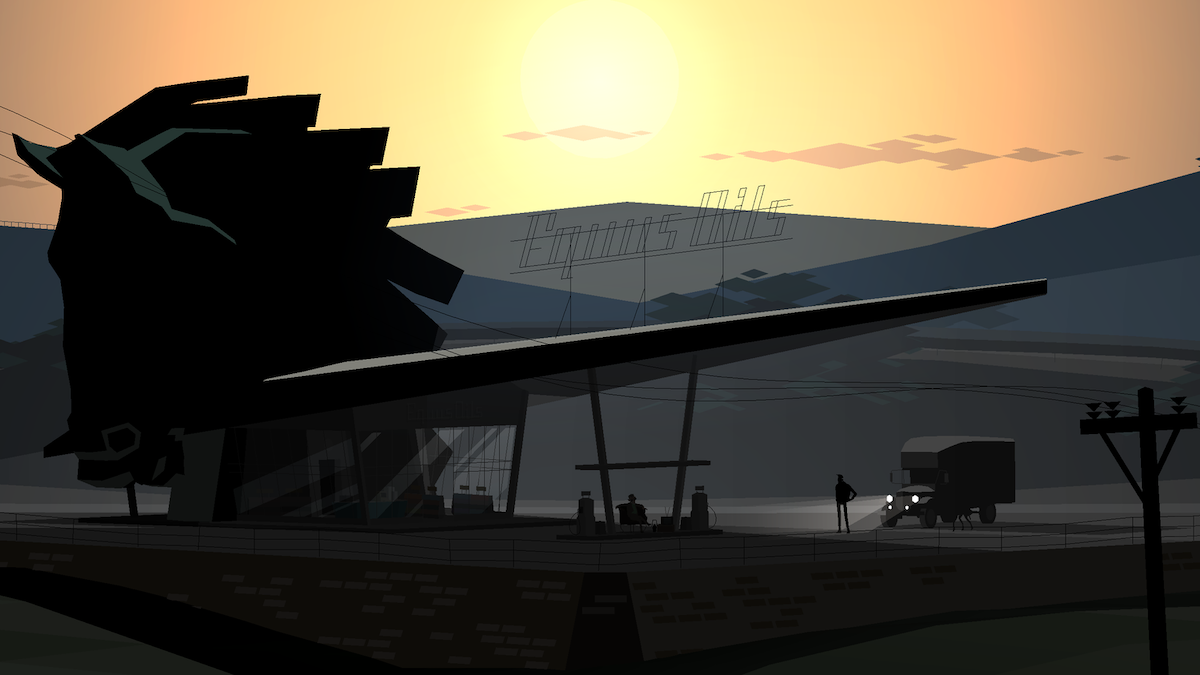Attenzione: evitate la lettura se non volete imbattervi in spoiler sulla prima stagione de La Legge di Lidia Poët
Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
A ormai due mesi scarsi dalla distribuzione su Netflix, si può affermare senza aver paura d’essere smentiti: La Legge di Lidia Poët è una scommessa vinta e si posiziona legittimamente tra le migliori produzioni italiane nella storia della piattaforma di Los Gatos. Una miniserie vera e solida, coraggiosa nel proporre una narrazione al passo coi tempi, audace nel combinare il passato col presente, efficace nel non scadere mai nei soliti difetti che ancora oggi caratterizzano – troppo spesso – le produzioni televisive del nostro Paese. Il pubblico, copioso e generoso nel dispensare recensioni positive, ha accolto bene il crime storico sui generis e l’interpretazione di Matilda De Angelis, protagonista nei panni di Lidia Poët, ha convinto buona parte dei critici. Insomma, un bel capitolo nel processo di modernizzazione dei linguaggi nostrani: un’internazionalizzazione che mira alla fuoriuscita dai confini provincialisti attraverso un racconto brillante, ironico e coinvolgente, in cui una colonna sonora che sembra ispirarsi ai codici espressivi già proposti in precedenza da Peaky Blinders ricopre un ruolo di primissimo piano, dirompente e sensuale.
Ben venga La Legge di Lidia Poët, quindi. Ma c’è un ma. Un ma gigantesco, un ma ingombrante. Ma… Lidia Poët non c’è. O meglio, c’è e non c’è. Principalmente non c’è. Anche se Lidia Poët è esistita sul serio e ha scritto alcune tra le pagine più significative della storia contemporanea d’Italia.
Come riporta anche la serie Netflix, infatti, è stata il primo avvocato donna del nostro Paese. A cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in un contesto storico in cui l’idea che una donna potesse permettersi di prendere una laurea veniva accolta con una certa derisione e il conservatorismo patriarcale imperava senza esser messo in alcun modo in discussione. In questo senso – e non solo in questo senso – la figura chiave di Lidia Poët, dotata di una vis rivoluzionaria a dir poco necessaria, ha ricoperto un ruolo straordinario. E merita d’essere raccontata, omaggiata e spiegata a fondo per riscoprirne la centralità anche nel nostro di mondo, sempre più reazionario e incapace di accogliere le istanze di un nuovo millennio che bussa vanamente alle porte da decenni mentre noi ci giriamo dall’altra parte, facciamo finta che il Medioevo non sia mai finito e il Rinascimento abbia solo giocato con un destino già scritto. Ben venga quindi La Legge di Lidia Poët, lo ripetiamo. Ma c’è un problema: noi non abbiamo visto una serie biografica, affatto. Abbiamo visto una bella serie, liberamente ispirata a Lidia Poët. Purtroppo, troppo liberamente.

È sufficiente dare un’occhiata alla pagina Wikipedia dedicata a La Legge di Lidia Poët per farsi un’idea di cosa sia andato storto nell’accoglienza destinata alla produzione. Citiamo: “La serie, pur a fronte di un ottimo risultato in termini di spettatori, è stata criticata dai parenti ancora in vita dell’avvocata, suscitando inoltre critiche negative per l’offuscamento delle sue origini valdesi, per l’utilizzo superfluo di espressioni volgari e – in generale – per la scelta di ridimensionare l’importanza della giusta contestualizzazione storica”. Si esagera? Per certi versi sì: in particolare, l’utilizzo del turpiloquio ha un senso narrativo che va oltre la colorazione di una sceneggiatura e rappresenta un ricercato elemento di sostanza. Come spiegato anche dal nostro Gianpaolo Torchio nel corso di un’intervista che rappresenta un riferimento fondamentale nello sviluppo delle argomentazioni qui proposte: una brillante intervista a Clara Bounous, storica, studiosa e scrittrice, tra le prime a occuparsi di Lidia Poët e autrice di due importanti libri sulla sua figura.
Si esagera, quindi. Ma non più di tanto. Perché chi ha conosciuto bene l’avvocata, personalmente o meno, non ha apprezzato l’adattamento creativo della sua biografia, e non è difficile comprendere perché: di Lidia Poët, ne La Legge di Lidia Poët, c’è poco più del suo nome e dell’avvocata che ha impegnato una vita intera per riscrivere le miopi convenzioni di un’Italia incapace di muoversi tra i necessari sobbalzi del tempo. È un peccato, perché svilisce una produzione che ha mostrato una certa ingenuità sul piano gestionale, di fronte a una scelta di fondo che avrebbe potuto aggirare tranquillamente ogni problema e avrebbe lasciato spazio ai soli – sacrosanti – elogi che una serie tv del genere merita: sarebbe stato sufficiente, infatti, chiamare la protagonista con un altro nome.
La Legge di Lidia Poët, in sostanza, non doveva essere una storia vera. Oppure doveva esserlo sul serio.

Se la serie si fosse liberamente ispirata alla figura di Lidia Poët, senza utilizzare pretestuosamente i rari cenni biografici riportati all’interno di un racconto che si è posto obiettivi differenti dal racconto di una vita straordinaria, non ci sarebbe stato niente da dire: avrebbe valorizzato le peculiarità che ne hanno reso intrigante la visione, accendendo allo stesso tempo i riflettori su una donna ingiustamente snobbata dai nostri libri di storia. L’avrebbe omaggiata senza mancarle in alcun modo di rispetto, permettendo ai più curiosi di approfondire in separata sede la sua vera storia. Perché no, anche attraverso una seconda produzione, da sviluppare all’interno di un genere in cui Netflix ha mostrato a più riprese di essere maestra: la docuserie. Sennò attraverso un’altra serie, onestamente biografica, da affiancare al particolare ibrido creato ne La Legge di Lidia Poët. Sarebbero state serie allo stesso modo necessarie, tra loro compatibili e altrettanto performanti: Lidia Poët, la vera Lidia Poët, sarebbe stata trattata nel modo dovuto, raccontata al meglio e de La Legge di Lidia Poët sarebbe rimasta solo una bella storia, di fantasia, esplicitamente ispirata in modo libero alla vera storia senza subirne in alcun modo i vincoli. Perché non è stato fatto? Perché si è caduti in un errore tanto grossolano che si sapeva in partenza avrebbe portato con sé le polemiche che ha poi ovviamente generato?
Si cercava questo risultato, con una certa malizia, per richiamare l’attenzione su una produzione che altrimenti avrebbe rischiato di passare in sordina ed essere dimenticata nel mare magnum del catalogo Netflix?
Solo i responsabili della produzione potrebbero dare una risposta chiara in questo senso, ma ci permettiamo di nutrire dei dubbi, al di là di tutto: l’audacia de La Legge di Lidia Poët, una serie dotata di un naturale carisma e una spiccata personalità, avrebbe avuto tutte le carte in regola per esplodere comunque, imporsi agli occhi del grande pubblico e ottenere pari successo, a prescindere da Lidia Poët. Raccontando la medesima storia, con le medesime licenze narrative e la brillantezza espositiva che può – anzi deve – prescindere dai canoni solitamente applicati per serie tv di questo tipo. Dispiace, perché si è finito col parlare delle polemiche intorno a La Legge di Lidia Poët più della serie stessa. E si è finito col scontentare un po’ tutti per motivazioni differenti, mentre avremmo potuto unirci in un coro più o meno unanime nel ringraziare autori e interpreti per aver portato in alto la bandiera tricolore su una piattaforma che ha spesso avuto più di un problema nel restituirci dei prodotti di qualità nostrani. Non sarà l’eventuale seconda stagione a cambiare le carte in tavola in questo senso: quel che è fatto è fatto e ricercare un risultato più fedele alla storia originale porterebbe con sé l’indispensabilità di una serie che non merita in alcun modo d’essere snaturata.
Allora fermiamoci qua, con un rimpianto. E una consapevolezza: spesso, in Italia, finiamo per sbagliare anche quando facciamo le cose per bene. Purtroppo, per qualche motivo, è parte del nostro Dna, tendente nella stessa misura alla bellezza e all’autosabotaggio. Che peccato.
Antonio Casu