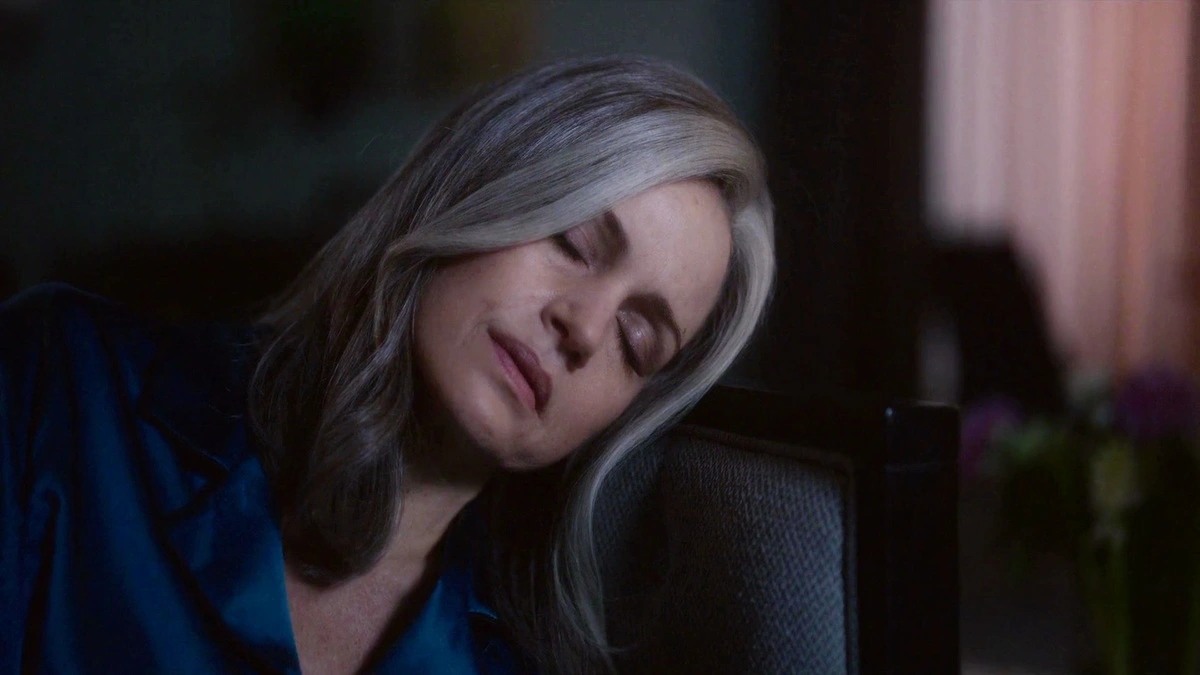Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
L’identikit del regista di prodotti come Absentia o Ouija non poteva che corrispondere al più veemente appassionato del genere horror in tutte le sue forme e sfumature. Parliamo di Mike Flanagan, che indubbiamente stimolato dalle storie di Streghe e demoni della città che gli ha dato i natali, ha desiderato già dalla giovane età imprimere lo stile dei suoi racconti attraverso parole e immagini. Ed è per questa e altre ragioni che alla Townson University conseguirà una laurea in media elettronici e film oltre a specializzarsi in un corso di teatro.
Diventerà così un cineasta a tutto tondo! Capace di emergere in tutti i ruoli del mestiere, mettendosi in gioco dalla regia alla sceneggiatura fino a produzione e montaggio. Tutto ciò che deriva da una sua idea diventa una creazione originale in cui imprimere in ogni caso la sua singolare firma d’autore. In termini di serie tv Mike Flanagan ha stipulato un patto con Netflix che gli ha offerto parte del suo spazio multigenere, concedendogli così il vero titolo di “signore della notte”. Pertanto, al di là di qualche screzio con la piattaforma circa la richiesta del regista di trasferire anche su supporti fisici le sue stesse produzioni, gran parte del suo successo lo deve anche all’hype creato dai canali social della piattaforma.
Oltre le atmosfere gotiche, indipendenti dallo spasmodico uso di jump scare
Mike Flanagan si fa coinvolgere nella trasposizione cinematografica di prodotti letterari. Inutile dire come Stephen King sia uno degli scrittori prediletti da Flanagan. A tal punto da ispirarsi a lui svariate volte se consideriamo Il gioco di Gerald o Doctor Sleep. Ultimamente ha portato a termine anche l’acquisto dei diritti de La Torre Nera, una serie di romanzi fantasy del colossale autore che prossimamente vedremo su Prime Video. Tuttavia è sulla serialità che ha avuto la presa più forte sul pubblico e nonostante tutti i 5 prodotti abbiano avuto un meritato successo, qualcuna di queste ha ricevuto più elogi di altre.
Come se fosse un climax discendente di flebile critica, iniziamo il nostro viaggio nel mondo cupo e spaventoso di Mike Flanagan. Facendo dunque una classifica dalla sua serie “peggiore” fino a giungere al suo fiore all’occhiello. Se siete dunque deboli di cuore, vi consiglierei di prepararvi a qualche brivido di troppo lungo la schiena. Se invece non aspettavate altro che provare emozioni forti, benvenuti a Hill House e da quella porta sulla destra vi troverete di fronte al lago di Bly Manor.
Qui un sacerdote vi adescherà con discorsi sulla fede invitandovi alla sua Midnight Mass, ma so già che alla stessa ora preferirete partecipare invece ad uno degli incontri del Midnight Club. Sbaglierete sicuramente piano però e vi ritroverete in una grande sala con Edgar Allan Poe che farà da maggiordomo alla famiglia Usher oramai in rovina tra scandali e misteri irrisolvibili.
Che trip ci fa mettere su il nostro Mike Flanagan! Ma badate bene che questo, era solo l’inizio.
5) The Midnight Club viene schiacciata dal suo stesso desiderio di vincere la morte

Infinitamente delicata e ambiziosa è stata l’idea di mescere le storie dell’orrore più paurose e articolate, al dramma senza paragoni della malattia terminale. Se ad esserne vittime poi sono dei giovani ragazzi, il genere si colora ancor di più di toni angoscianti e intrisi di rassegnazione. L’iniziale idea di Mike Flanagan era infatti quella di esorcizzare (non a caso!) la paura di questi inermi adolescenti inserendoli all’interno di una storia young adult (qui un articolo a riguardo), fatta di amicizia, investigazione, condivisione e forte paura. Questa, legata alle terribili storie raccontate in ognuno dei dieci episodi, aveva l’obiettivo di superare quella più morbosa e taciuta della loro attuale condizione.
Nelle narrazioni che vanno dal ghost tale al demonico passando anche per il crime, c’è una implicita componente autobiografia legata al tragico destino di chi le racconta. Mike Flanagan crea così un’inception narrativa che permette di innestare nella cornice già orrorifica della serie anche le singole storie attraverso visioni oniriche e allucinatorie. Ad aggiungere un ulteriore strato investigativo è Ilonka, la perspicace protagonista che emergerà più degli altri amici della mezzanotte insieme alla fragile ma temeraria compagna di stanza Anya. Sarà suo obiettivo infatti scoprire cosa si nasconde nel sinistro passato del Brightcliff Hospice, che da indisturbato collegio di villeggiatura per giovani sfortunati, si rivelerà più fitto di misteri dei racconti del Club. Come dimostra a primo impatto la parlante presenza della regina dell’horror Heather Langenkamp.
Le dieci storie sono tutte ispirate ai romanzi di Christopher Pike
E probabilmente uno dei primi errori è stato compiuto proprio nell’adattamento di questi. Di fatto il nostro regista, seppur abbia diretto solo i primi due episodi per poi lasciare spazio a Leah Fong, ha come dissacrato all’estremo il fulcro della battaglia contro la malattia. In quanto, cercando di eliminare ogni tipo di compassione patetica, ha deviato troppo il pubblico e gli stessi personaggi dal rispetto verso la delicata condizione che erano costretti a vivere.
Eludendo quasi ogni riferimento alla morte e scongiurandola anzi con il valore apotropaico della possibile comunicazione dall’aldilà con i vivi, sembra quasi presentare quei ragazzi più deboli di quanto in realtà non siano. Evidenziando come il loro incontrarsi per affossare la loro inquietudine in altrettanti flussi narrativi macabri, non desse loro quell’audacia di ammettere con coscienza l’insorgere del morbo nelle loro vite innocenti. Tutto risulta così più amaro di come ce lo vende il Club e l’idea aleatoria di sopportare la sofferenza e il male pazientemente e pacificamente, risulta poco credibile e macchinosa per certi versi.
Dai tratti quasi farseschi è infine l’uso incontrollato dei famosi jump scares
Entrando dunque in contrasto con il desiderio di Mike Flanagan di applicarne in maniera sempre più esigua. Qui dunque abbondano con l’obiettivo di annullarne il loro stesso significato, come lui stesso ha giustificato. Tuttavia questa affermazione non sembra bastare a naturalizzare l’onda narrativa che risulta già prorompente per sua natura.
Pertanto niente di inaccettabile o eccessivamente provocatorio in fin dei conti si annovera in The Midnight Club. Nonostante questa, alla fine della prima stagione, sia stata però troncata in maniera troppo secca senza possibilità di rivalsa in un futuro prossimo. Avremmo probabilmente preferito una più realistica empatia e forte sensibilità simile a quella diffusa nella nostrana Braccialetti Rossi? Chi può dirlo. La verità è che della sua forte carica di terrore non ne avrebbe potuto mai farne a meno. Fortunatamente di Mezzanotti nelle creature di Mike Flanagan ce n’è in abbondanza, quindi questo non può risultare comunque un fallimento completo, se i termini di paragone sono elevati sopra ogni misura.
4) Con The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan ce l’ha fatta di nuovo

Ci troviamo infatti al cospetto della seconda stagione antologica e quindi indipendente prodotta dopo l’inimitabile Hill House. Ispirata al romanzo Il giro di vite di Shirley Jackson, la storia risulta ugualmente inquietante e dai fulminanti tratti horror come la prima stagione. Tuttavia ad emergere è una più pregante sfera emozionale e psicologica. Si tratta ovviamente di un ammodernamento, fermo però all’Inghilterra degli anni ’80, del romanzo ottocentesco di provenienza. Qui la protagonista è un’istitutrice di nome Dani che viene assunta da un anziano avvocato per i due nipoti rimasti orfani dei genitori. La dispersiva e gelida dimora di campagna intorno a cui ruotano le vicende non manca anche in questo caso di attirare i più appassionati del genere horror. Creando in loro un penetrante senso di smarrimento sostenuto anche dalla poliedrica prospettiva da cui si dipana la storia.
Si può trattare infatti di una narrazione piuttosto corale. Questa infatti si districa dal punto di vista principalmente di Miles e Flora, le due tenere ma inquietanti stars, fino a toccare la visuale delle manifestazioni stesse del male. Il formato della prosa risulta assai frammentato proprio perché non può essere lineare nulla che parli di disgrazia, odi et amo ed ossessione. Tanto che il montaggio risulta piuttosto ambizioso e audace, affinché la confusione si innesti in chi guarda anche più della paura. Qui la reiterazione di situazioni e ricordi la fa da padrona, ma risulta comunque coerente con l’ardita e disattesa scelta di creare un plot twist con un salto nel futuro di 20 anni. Nel 2007 vediamo infatti una donna che racconta la storia a cui il pubblico aveva già assistito ma che di fatto sembra quasi non riconoscerla più.
Come conclusione d’effetto Mike Flanagan ha regalato sul finale una terza via
Rendendolo non privo delle più disparate interpretazioni e riflessioni, le quali riescono comunque a stringere dei nodi nel perimetro della trama affinché questa non si sfilasse del tutto. Ma detto ciò, perché ha funzionato “meno” di Hill House? La prima verità da ammettere è che Bly Manor sembra non narrarci nulla di troppo originale e sorprendente. Potremmo quasi definirlo un esperimento riuscito in quanto grande classico, per via delle categorie di appartenenza dei personaggi e delle dinamiche che li legano. Così come gli stessi elementi volti a innescare melanconia e irrequietezza risultino subito riconoscibili.
È stato lasciato sicuramente più spazio allo stile e ai messaggi di Shirley Jackson. Realizzando così una ricetta che sembrasse del tutto rivisitata da quella tradizionale ma che tenesse quello stesso profumo acre. Che ci sia riuscito o meno non possiamo affermarlo in maniera immediata. Un esperimento riuscito, dunque, ma che forse paga il confronto con una prima stagione che ha dell’iconico e intramontabile.
3) La caduta della casa degli Usher non è stata così dolorosa per Mike Flanagan

Di arene simboliche protagoniste insieme ai personaggi dei suoi più macabri racconti, l’Alfred Hitchcock dei nostri giorni sembra non averne mai abbastanza! Stavolta infatti la casa di cui si parla è più descritta come la culla di una grande famiglia snaturata, ipocrita e a tratti mefistofelica. Incastoniamo infatti nella solita cornice intensamente thriller le tematiche di salute e scienza farmaceutica. È infatti il Ligodone il focus su cui ruotano i misfatti e il fallimento di questa famiglia di magnati senza scrupoli. Antidolorifico che a loro dire non avrebbe dovuto provocare dipendenza, senza però considerare come l’assunzione di questo in quantità eccessiva, come è solita fare Juno, possano provocare un’assuefazione fatale.
A tenere le redini imprenditoriali e familiari sono sicuramente i fratelli Roderick e Madeline. Lei in particolare è esponente della parte tecnologica della produzione, nonché vicina al peculiare e invasivo settore dell’intelligenza artificiale. Lui ha due figli legittimi e altri quattro riconosciuti ufficialmente come membri della famiglia dopo poiché avuti con diverse amanti. Ognuno di questi, ai quali vengono dedicati gli episodi finali, sembrano non avere la giusta stoffa per seguire gli affari di famiglia. Vero è che la mela non cade mai lontano dall’albero e la loro potrebbe presentarsi come una sorte di ribellioni nei confronti del padre autoritario e mitomane.
Questi infatti non ha mai ricoperto il ruolo di padre dedito alla crescita dei figli
È stato soltanto un boss che ha creato in loro non poche rivalità e ha infestato di tossicità anche le loro relazioni extra familiari, riempiendoli di vuoti e insicurezze. A questo proposito una tematica importante che emerge è proprio il conflitto generazionale e l’impossibilità tanto attuale di colmare il gap che sembra dividere in maniera sconsiderata le diverse epoche umane. Pertanto se non è Roderick a dare onore all’autorità paterna, il vero capo famiglia è qui l’indiscusso Edgar Allan Poe (qui ne parliamo). Questi con i suoi racconti noir posseduti da grottesco e terrore assoluto segnano il susseguirsi degli episodi. Mediante il genio e l’arte del poeta maledetto e romantico per eccellenza, Mike Flanagan ha infatti seguito le sue orme espressive per una scrittura raffinata ma dai contorni decisi.
Sublimi e magistrali risultano non a caso i dialoghi tra i personaggi. Volti ad esaltare la sottile ma puntuale denuncia socio-culturale verso gli impliciti argomenti del consumismo contemporaneo. Il quale, misto al potere demoniaco che sembra acquisire sempre più il denaro, segna un vero momento storico dal quale sembra impossibile ormai tornare indietro. Detto ciò, mancano obiettivamente le scelte di montaggio rocambolesche e la ricerca della suspense finalizzata a far saltare il cuore in gola tipici di Mike Flanagan. Di fatto è il dramma familiare dalle note dark a prendere il sopravvento, riuscendo comunque a trasmettere soluzioni suggestive e funzionalmente immaginifiche.
Per farlo non rinuncia questa volta ad infondere in ogni lembo del racconto il suo stile
Nonché la personale tendenza a lanciare spunti di riflessione filosofici, economici e morali. In questo modo non avvertiamo in nessun momento l’imitazione pedestre degli scritti di Allan Poe. Ma piuttosto una loro rielaborazione volta a dargli forte adito con umiltà ma estrema padronanza della materia trattata. Inoltre a non mancare è la presenza anche di altri spunti. Come quelli che ricordano la miniserie Painkiller (qui ne parliamo) o rimandano a qualche qualche passaggio di Succession. Appagati dunque dalle lodevoli doti narrative di Mike Flanagan, assaporiamo lentamente quello che questa serie ci ha dispensato in piccole dosi un episodio dopo l’altro. Presagio che qualcosa di ancora più grande ci offrirà in dono il nostro regista e che le nobili considerazioni per le sue creazioni sono soltanto iniziate.
2) Midnight Mass la dice lunga su fanatismo e dintorni del Cristianesimo

Siamo quasi agli sgoccioli di questa classifica e il rischio di un ex equo per il primo posto poteva essere alto. Parliamo qui dell’unico prodotto seriale di Mike Flanagan originale nel senso letterale del termine. In quanto, a parte qualche vacuo riferimento al maestro King da lui sempre idolatrato, risulta essere frutto della sola creatività del regista. Parliamo di una storia ispirata, come lui stesso afferma, dall’educazione cattolica ricevuta in gioventù e dal suo conseguente ateismo. Così come ahimè, dalla sua probabile lotta con la sobrietà.
L’arena questa volta non è un luogo circoscritto come le mura di una casa, di una villa o un’istituto per malati terminali, ma un’isoletta abitata da poche anime. Tuttavia è proprio Crockett Island a risultare per certi versi più asfissiante di tutte le location appena elencate. Quando al piccolo centro costruito sulla base di pettegolezzi, etichette, ipocrisie e invidie, si unisce pure il fanatismo religioso, il disastro è annunciato.
Ecco che Padre Paul diventa così il dio in terra dei fedeli abitanti dell’isola
Incuranti di quali fossero le sue vere origini e dello strano baule che ha portato con sé dal suo primo giorno sull’isola. È stato infatti molto scaltro il sacerdote a sfruttare la preoccupazione per la carestia di pesca pre potersi così insinuare in maniera subdola e malsana nelle vite delle persone. Spacciando miracoli e discorsi di speranza e amore, si è così comprato la fiducia di persone umili e per lo più ignoranti. Ma qual è il prezzo da pagare alla fine dei conti? Saranno gli outsiders del posto, come Riley Flynn ed Erin Greene, interpretata dalla brillante moglie di Mike Flanagan, a vederci più lungo degli altri. Empatici e complessi come soltanto chi si è spostato dall’isola per poi tornarci controvoglia può davvero essere.
Sarà quindi in questa plumbea e assopita cittadina, che la fotografia applicata magistralmente emerge con prorompenza. Più dei contorti discorsi di Padre Paul e del montaggio che risulta pressappoco lineare. Michael Fimognari torna infatti a collaborare con Mike Flanagan pronto a spargere lo schermo di colori freddi e claustrofobici. Alternando tuttavia mare e sole luminosi, per smorzare i toni quando risulta necessario.
Questo esalta l’ormai riconoscibile modus operandi di Mike Flanagan
Il quale tende a riconfigurare l’involucro horror in modo da poter parlare anche e soprattutto di altro. In questo caso l’obiettivo e vivisezionare le diverse componenti della tradizione cristiana. Questa di fatto è costruita in parte su amore, perdono e speranza e per tutto il resto su tradimenti, falsità, nefandezze e perché no, vampirismo! La fede viene descritta come frutto per lo più di una costruzione culturale tramandata per generazioni in ogni parte del mondo. Divenendo dunque universalmente ambigua e non priva di situazioni irrisolte.
Pertanto anche in questo caso si lascia più spazio a tensione crescente e suspense, piuttosto che al brivido gelido o allo spavento improvviso e disarmante. Sono troppo scottanti le tematiche trattate e appesantirle ulteriormente con tutte le caratteristiche proprie del genere, sarebbe stato un tentativo malsano per la naturale fruizione della vicenda. Una costante resta però il finale un po’ amaro e volutamente incompiuto, che tutto fa pensare però tranne che ad un filo sospeso. Restiamo infatti soddisfatti delle verità finalmente svelate e dei plot twist incontrati. Ma è però la nostra mente probabilmente a venire stuzzicata dall’inconscio desiderio di scoprire un ipotetico prosieguo. Resta comunque chiaro che essendo una miniserie è così che doveva concludersi. Ed essendo una storia tutta d’un pezzo e poco aleatoria come le altre, non è possibile neanche prevedere una seconda stagione con lo stesso fil rouge ma strutturata su dinamiche differenti.
Possiamo infine asserire che la formula magica di Mike Flanagan qui pullula da tutti i pori
Così come il suo acume autoriale, le sue conoscenze religiose e filosofiche e le sue più affezionate fonti di ispirazione. Passando dall’analisi della Bibbia a Nietzsche in poco tempo e maneggiando sempre con cura i delicati argomenti trattati. Dietro un grande filmmaker, qualsiasi siano i prodotti che si impegna a confezionare, sono infatti sempre necessari studio, tecnica e cultura settoriale. Ciò nonostante l’importante è che a tenere le redini sia sempre la passione. Il talento da solo è già tutto. Ma se affinato con la giusta dose di disciplina e teoria, diventa una vera e propria arma bianca volta a falciare ogni possibile concorrenza e prevaricazione da parte di chi, non possiede gli strumenti giusti per fare vera arte. Perché di questo si tratta.
1) The Haunting of Hill House vince la sfilata degli orrori drammatici di Mike Flanagan

Ebbene sì, siamo arrivati al traguardo finale di questa maratona da brivido. Abbiamo inciampato in storie di spettri, vampiri, demoni e persone comuni, unite da legami familiari o di amicizia. Ma è soltanto Hill House a racchiudere tutto questo e molto di più. Abbiamo avuto infatti la fortuna di vedere approdare su Netflix la prima vera serie tv horror per eccellenze. Questo Mike Flanagan poteva immaginarselo vista la profonda dedizione estetica e autoriale conferitagli, ma sicuramente non aspettava lo smisurato successo. Seppur i primi episodi mantengano infatti un ritmo abbastanza lento e rivolto alla presentazione introspettiva dei membri della famiglia protagonista della storia, è dal sesto episodio che tutto cambia.
Da questo momento in poi infatti ha inizio per chi guarda una cavalcata fatta di cliffhanger e suspense estremi. Realizzate dal realismo di un dramma familiare lacerante che sottolinea il duplice piano temporale su cui la storia si dipana. Una storia di innocenza e inconsapevolezza dei coniugi Crain e dei cinque figli piccoli, che renderà possibile la conversione della storia ispirata a Shirley Jackson in una ancestrale fiaba gotica. E sono proprio i bambini più degli adulti ad avvertire sin da subito il potere malefico e subdolo della casa. Nonostante la prima vittima e carnefice fosse proprio la madre interpretata dalla leggendaria Carla Cugino. Ricercate sono inoltre le citazioni di prodotti maestri, discendenti dall’abile mano di King, Poe e grandi filosofi. Tali da non rendere soffocante e monografica la trasposizione letteraria de L’incubo di Hill House.
A non essere unidirezionali sono anche le specifiche del genere predominante
In quanto, alla fine della serie Mike Flanagan ha saputo iniettare alla trama quel senso di universalità che abbraccia più sottotrame come la morte, il soprannaturale, il tormento. Tutte funzionali e quindi indispensabile a rendere il prodotto finito ricco di qualità. Questa viene conferita come nella maggior parte dei suoi capolavori da una sceneggiatura studiata e fluida, seppur spesso avanguardistica e volutamente oscura. È però il cast a valorizzarla risultando pertanto stellare in entrambe le linee temporali, elemento ancora una volta ben trattato e mai farraginoso nell’economia della storia. Vengono descritti infatti come personaggi a tutto tondo, sia insieme che singolarmente. Dediti a combattere con i loro mostri dopo aver passato metà della loro vita a vederli davvero.
Anche il montaggio, che viene in aiuto della fotografia iper espressiva, risulta pedissequo alla storia. Seguendo passo passo la tonalità degli episodi e rendendo possibili i diversi significati che ognuno di loro vuole trasmettere. Nella prima parte della serie abbondano efficaci piani sequenza come nell’iconico episodio Due temporali, uno dei più articolati fatto di presente, passato e pioggia incessante. A metà serie Mike Flanagan ci risveglia portandoci a saltare sulla sedia con i suoi misurati jump scares (qui ne parliamo) , ma non solo. Ci fa commuovere senza riuscire a tirare fuori i nostri occhi ormai penetrati nello schermo.
Non dimentichiamo inoltre i simbolismi che si celano dietro la narrazione
Sono le visioni e le parole a coltivarli sin dal principio, rendendo la serie eterna e reale più che mai. Attirano il suo pubblico che non riesce a smettere di fare ipotesi, seguire piste e cercare di afferrare i veri significati che un genio come Mike Flanagan vuole suggerirci. Questi vanno dalla porta rossa come iconica concretizzazione del terrore alla stessa madre Olivia. Proprio lei, ai limiti dell’essere apprensiva e traviata dal paranormale, vuole proteggere i suoi figli dal loro stesso futuro. Tuttavia fa loro del male esattamente come la casa, che apparendo all’inizio un luogo affascinante e sicuro si rivela essere l’unico spazio in cui davvero non si può vivere un’istante di più.
Tutto diventa così ansiogeno ma trepidante in vista del finale e delle verità che ci svelerà. Queste arriveranno puntuali per noi, anche se qualche premonizione verrà tradita e qualche nuova considerazione emergerà fuori. Mantenendo sempre l’obiettivo però di dare una chiusa originale e non poco definitiva. A differenza invece del romanzo che ci concede un finale dai tratti più astratti per non dire onirici. Facendoci quasi dubitare dell’intero vissuto dei protagonista in quella casa maledetta e dei loro drammi. Non si può negare infatti che molti di noi si siano chiesti se tutto quello a cui avevamo appena assistito potesse essere soltanto frutto delle paranoie e del lutto di menti giovani e quindi plasmabili.
A noi però piace credere che quello che c’è stato non si può dimenticare
E segnerebbe il destino di chiunque senza ombra di dubbio. Quindi con il pensiero cerchiamo di connetterci a loro, vittime o complici che siano! Ringraziandoli degli insegnamenti che anche nelle peggiori situazioni sono riusciti a trasferirci senza condizioni. Il ringraziamento vero però va solo a Mike Flanagan. Questi instancabilmente ha mantenuto alta la sua fede nell’orrore, cercando sempre di alleggerirla con antidoti nati per combattere la monotonia narrativa.
Ci ha portati dentro la sua testa e ci ha fatto toccare con mano la paura di personaggi divenuti sin da subito esseri umani reali come noi. Una paura mai fine a se stessa, lontana da quei termini moderni e vuoti come “splattering” e titoli che dicono tutto e niente. Gli artisti sono spesso incompresi e inquieti, tristi e vittime di maledizioni che si autoinfliggono il più delle volte. Il nostro Mike, con il suo sorriso sornione e il cipiglio rilassato, ci dimostra che esattamente come la luna, la sua vera faccia non si vede ad occhio nudo. È quella nascosta dall’ombra.