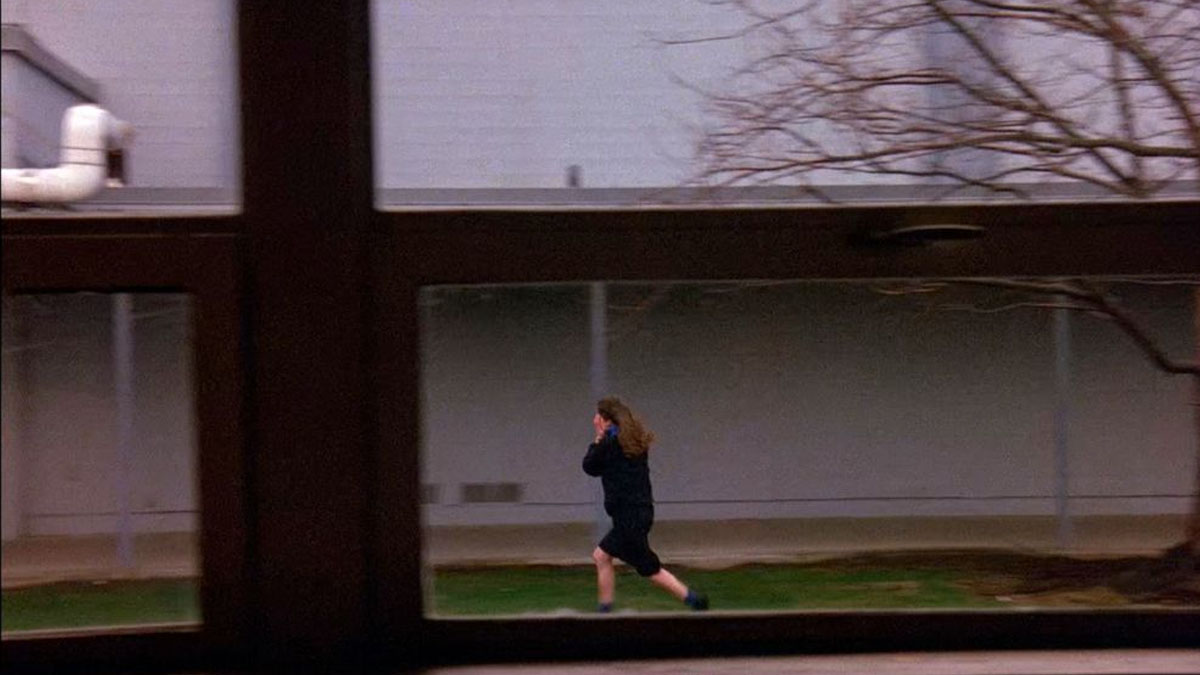Un abbonamento che cambia il tuo modo di guardare le Serie Tv
Con così tante piattaforme e poco tempo a disposizione, scegliere cosa vedere è diventato complicato. Noi vogliamo aiutarti ad andare a colpo sicuro.
Arriva Hall of Series Discover, il nostro nuovo servizio pensato per chi vuole scoprire le serie perfette i propri gusti, senza perdersi in infinite ricerche. Ogni settimana riceverai direttamente sulla tua email guide e storie che non troverai altrove:
- ✓ Articoli esclusivi su serie nascoste e poco conosciute in Italia
- ✓ Pagelle e guide settimanali sulle serie tv attualmente in onda
- ✓ Classifiche mensili sulle migliori serie tv e i migliori film del mese
- ✓ Consigli di visione personalizzati e curati dalla nostra redazione (e non un altro algoritmo)
- ✓ Zero pubblicità su tutto il sito
ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’OTTAVO EPISODIO DELLA TERZA STAGIONE DI TWIN PEAKS
L’episodio numero 8 diTwin Peaks – The Return è una ricca enciclopedia visiva attraverso la quale abbiamo il privilegio di esplorare in punta di piedi la mente di David Lynch, il suo funzionamento e le sue idee, i suoi misteri e i suoi incubi. Per compiere questo viaggio all’interno del processo creativo del regista dobbiamo provare a spegnere la razionalità, interrompere il flusso di domande senza risposta che vengono a galla durante la visione, accettare l’ignoto e il non detto, l’enigma e il surreale.
Dobbiamo essere spettatori sospesi tra due mondi, quello dell’inconscio e quello del cosciente e accogliere con assoluta cessazione di giudizio ciò che accade davanti ai nostri occhi. Non si può valutare l’automatismo psichico tanto caro ai Surrealisti, di cui Lynch è stato il grande erede della contemporaneità. Si può solo ammirare, come quando vediamo un fiore sbocciare o un’esplosione di una Supernova nello Spazio profondo. Avvengono, spontaneamente.
Ed ecco quindi che sullo schermo davanti a noi compare un’altra deflagrazione: quella della bomba atomica testata in New Mexico nel 1945. Un movimento impazzito di atomi che freneticamente rimbalzano e schizzano da un punto all’altro dell’immagine. È sperimentazione cinematografica. È videoarte degli anni ’70. Lentamente ci troviamo dentro l’ordigno nucleare, di cui ne siamo inspiegabilmente ipnotizzati. Ma che ci provoca anche un senso di destabilizzazione, complice la musica di accompagnamento “Threnody for the victims of Hiroshima” del compositore polacco K. Penderecki.
Uno stridore di 52 strumenti ad arco che graffiano aspramente i nostri timpani e le nostre coscienze, perché c’è qualcosa di terribilmente malvagio in quel fungo denso e compatto che si alza nel cielo. Il mondo è un posto in bianco e nero, non è così dal quel giorno di 80 anni fa? E lo sarà per tutta la durata di questo episodio di Twin Peaks, eccetto che per l’epilogo, ambientato nel presente e nella realtà concreta.

Lynch srotola i suoi pensieri liberamente, uno dopo l’altro, a rappresentare la Genesi del Male tramite il linguaggio estetico delle Avanguardie e delle Neoavanguardie del ‘900. Ma che cos’è il Male? Una malattia fisica? Un dolore insopportabile? Un’azione compiuta da una persona a danno di qualcun altro? Le domande rimbalzano tra le nostre sinapsi come quelle particelle di energia in cui distinguiamo il volto di Bob. E Bob è un essere che ha sembianze umane. Se ci pensiamo in Natura non esiste il concetto di buono o cattivo. Anche il predatore più abile uccide per sopravvivenza. Per tenere in piedi la ciclicità della catena alimentare su cui si basano le vite di tutti. Non c’è intenzione malevola, non c’è premeditazione. È puro istinto.
Diversamente, non possiamo dire lo stesso di ciò che avvenne in quel deserto nel luglio del ’45. E più in generale su scala globale con la Seconda Guerra Mondiale e tutto ciò che ha comportato. Una carneficina di soldati e di civili accanto all’orrore dei lager nazisti e alla folle corsa scientifica nella creazione dell’arma nucleare. Dapprima solo teorie sulla carta che passano dall’essere idee surreali e stravaganti a realtà fulgida e terribile, tangibile con il primo test in New Messico, ripreso da Lynch in questo episodio.
Ma se ogni cosa ha il suo contrario, anche nella dimensione onirica può esserci il bene moralmente inteso. All’interno di quella che potremmo ipotizzare essere la Loggia Bianca, ma che ha tutta l’aria di un teatro d’opera, guardiamo il Fuochista (o il Gigante) che guarda a sua volta lo scoppio della bomba atomica su di un grande schermo. Come nelle migliori invenzioni magrittiane, in cui l’osservatore guarda l’artista che dipinge l’opera, così noi spettatori osserviamo il Gigante mentre osserva, e mentre si addormenta lievitando da terra.

La sua mente, i suoi sogni probabilmente, creano un filamento dorato (l’unico colore dell’intera sequenza) che si distende e si ingrandisce fino a produrre un globo con all’interno il volto di una donna: Laura Palmer. È la Genesi del Bene, in cui la sfera lucente viene accolta teneramente nelle mani della Señorita Dido che le dà un bacio prima di lasciarla andare. La figura rotonda viene attirata da un grosso meccanismo fatto di ingranaggi, molto simile alle Macchine Inutili di Jean Tinguely, e da lì spedita sulla Terra.
L’automatismo di Lynch, fin qui in bianco e nero, diventa persino il negativo di una fotografia in tutta la parte dell’episodio 8 di Twin Peaks dedicata alla pompa di benzina e ai suoi oscuri abitanti. Essa è inserita in un luogo metafisico dove alcune figure camminano, appaiono e scompaiono, divenendo inafferrabili, sfuggenti, grottesche e inquietanti, proprio come i pensieri del regista. In quel limbo eterno di anime dannate un uomo emerge dalle tenebre della notte. Ha una sigaretta tra le labbra e con passo ondeggiante avanza facendo esplodere le teste di tutti coloro che trova sul suo cammino.
Nel frattempo una coppia di adolescenti si scambia il primo bacio, una signora sta pulendo il bancone di un bar dopo una giornata di lavoro e la radio sta trasmettendo una malinconica canzone degli anni ’30. Queste sono le prime sequenze in cui compare il dialogo inteso come conversazione composta di parole tra due persone. Ma c’è incomunicabilità tra gli esseri umani e il losco individuo che uccide senza rimorso. La sua voce alle orecchie dei passanti appare come un ronzio fastidioso, una specie di interferenza gracchiante. Non si può mettere in comunicazione il mondo onirico con quello tangibile. Solo l’artista può riuscirci.

L’omaggio di Lynch al cinema muto ed espressionista mostrato nelle scene all’interno della Loggia Bianca, qui viene sostituito dal Surrealismo nella sua forma più pura. La rana-falena che esce dall’uovo e striscia verso una finestra aperta, ricorda le locuste delle opere di quel genio eccentrico di Salvador Dalì. La cantilena pronunciata dall’uomo con la sigaretta all’interno di una stazione radiofonica, è flusso di coscienza, è scrittura automatica, non più figurativa ma letteraria:
«Questa è l’acqua e questo è il pozzo. Bevi a fondo e discendi. Il cavallo è il bianco degli occhi e oscuro all’interno.»
Questa frase, ripetuta più volte al microfono della radio, fa cadere in un sonno improvviso coloro che la ascoltano. O forse li fa svenire, l’interpretazione la lasciamo a voi. Così la ragazzina distesa addormentata sul suo letto accoglie la rana-falena nella bocca. Il seme del Male si introduce con ripugnanza nel corpo di una persona innocente e inconsapevole. Il Bene è stato inviato sulla Terra tramite lo strano macchinario della Loggia Bianca, ma anche il Male ha trovato il suo modo di insinuarsi viscidamente nella vita del nostro pianeta.
In questa dimensione notturna che sembra essere stata dipinta dal pittore americano Edward Hopper, l’unica fonte luminosa proviene dai lampioni e dalle luci al neon degli edifici. L’esibizione musicale dei Nine Inch Nails a cui abbiamo assisto all’inizio dell’episodio di Twin Peaks, ci ha incastrati qua dentro, in questo buio senza tempo. Ha fatto da ponte di collegamento tra le due realtà e non abbiamo modo di uscirne, come l’agente Cooper imprigionato nella Loggia Nera. In lontananza sentiamo un cavallo nitrire, ma non riusciamo a distinguerlo in quelle spesse tenebre impenetrabili che la notte porta con sé.
Siamo nel sogno e nell’incubo di David Lynch, il sognatore che sogna il proprio inconscio, le sue ossessioni e le sue paure e ce le mostra senza censure tramite un’espressione libera, esteticamente elevata, che ribalta i concetti di logica e di razionalità. Siamo il Bene, siamo il Male, siamo due giovani innamorati, siamo insetti ibridi, siamo figure senza nome, siamo un cavallo. Oppure non siamo niente di tutto questo, perché una volta svegli, quella realtà è celata ai nostri occhi. Sembra non esistere più, ma è solo nascosta dentro le note di una canzone o dietro a un tendone rosso. Quel sipario che si apre quando dormiamo e che si chiude durante la veglia. Come il mondo di Twin Peaks, come la mente di quell’artista incredibile che è stato David Lynch.